https://www.fabiosommella.it/wp/quel-carillon-della-coscienza-che-sapre-e-suona-nella-mente/

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

Trasversalità, contaminazioni culturali… di Fabio Sommella
https://www.fabiosommella.it/wp/quel-carillon-della-coscienza-che-sapre-e-suona-nella-mente/

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
Han finito di pranzare. Il ragazzo va di lá a studiare e lui pensa: “Quanto t’amo, figlio mio.” Poi istintivamente va comparando questo stato d’animo d’amore alla propria infanzia più lontana, ai suoi, a sua madre. E si rende conto che, in quel tempo a lui remoto, anche Lei – la madre di suo figlio – ancor non c’era. E quindi, ognor e sempre spontaneo, pensa: “Ma perché, se allora ancor non c’eri, anche adesso non ci sei più? Perché é già terminato il tuo tempo?”
Non resta che scrivere, non rimane che scrivere, comporre, piangere, in silenzio ossequioso e muto, attonito, come il trascorrer del tempo nella memoria.
Un attimo.
[Fabio Sommella, 1° giugmo 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
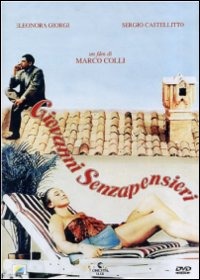
Un popolo esaltato e poi vilipeso dalla coscienza della Storia, quello di Roma; e, insieme a Lei – sacra e profana, colta e becera, aulica e cialtronesca, nobile e puttanesca, togata e stracciona… meravigliosa creatura, adagiata sui fin troppo celebratissimi sette colli e sulle rive del suo fiume -, la romanità tutta. Ciò – salvo rari laici illuminati momenti storici (le Repubbliche Romane del 1799 e 1849, la Resistenza) – è doppiamente vero: da una parte per lo storico potere temporale papale – ingombrante, scomodo, invadente e invasivo -; dall’altra per le altrettanto – latenti e subliminali, tuttavia evidentemente mai sopite – nostalgiche scomode ereditá imperiali (o, più propriamente, pseudo tali).
Sono queste due storiche polarità – solo in apparenza diverse, perché, seppure esclusive, mentalmente commiste (e su questo si potrebbe scrivere un trattato) – tali da provocare da una parte assopimento, senso di ottenebramento, dormienza secolare; dall’altra, viceversa, risveglio e senso di fierezza in nome di mai sopiti e latenti fanatismi. In merito penso sia superfluo fare riferimenti, essendo sotto gli occhi di tutti, sia per la storia più o meno recente che per l’attualità.
Nei momenti di Crisi – sociale, politica, economica – queste due alterne eredità – pseudoculturali, laddove si riducono a puro stereotipo e scappatoia, privi di contenuti e conoscenza – fanno breccia, puntualmente, nei cuori e nelle menti di molti, menti molli, le menti dei taciti nostalgici, dei misoneisti che temono il nuovo, degli incolti, dei rassegnati, dei derelitti, dei senza storia, dei senza scuola, di chi non vede al di là del proprio ristretto confine – sia questo il proprio giardino di casa o la propria nazione – di chi vede solo la sopravvivenza, il Mors Tua, Vita Mea.
Il mezzo cinematografico, anche finzionale, ha spesso fornito numerose metafore di questi aspetti storici. Rimanendo pur solo nel merito della storica influenza papale su Roma, tutta la sontuosa opera cinematografica di Luigi Magni è inquadrabile in quest’ottica. Ad esempio: il “Pippo Buono” di State buoni se potete, sorta di novello San Francesco, contrapposto agli Esercizi Spirituali di Padre Ignazio.
Tuttavia gli esempi filmici sono numerosi; un altro per tutti: il Giovanni Senzapensieri, 1986, di Luigi Colli, di cui sopra è riportata la locandina: racconto allegorico della Roma secolare e della sua dormienza, incarnata in un accidioso giovanotto, ultimo virgulto di un’aristocratica casata nobiliare, che, grazie a un tecnologico reperto leonardesco. simbolicamente antesignano di una scienza umana contrapposta al minante potere di un clero soffocante e orrendamente nero, ritrova la forza di spiccare il volo a discapito del proprio pregresso imbelle ottundimento.
A quando, miei concittadini contemporanei, il nostro volo?
[Fabio Sommella, 07 maggio 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

Di recente, a riguardo di tematiche cinematografiche, sento spesso parlare e vedo di nuovo scrivere del genere western; ciò avviene in diverse accezioni, talvolta negative; ad esempio: qualcuno sostiene sia un puro genere atto a distogliere le masse dall’attualità, da più impellenti problemi. In quest’ottica appare più nobile e idoneo fare film su mafia e camorra.
Io non lo credo. Ciò in quanto il significato trascende il genere e anche il contesto di ambientazione, i quali viceversa divengono metafore, strumenti atti a veicolare significati universali e atemporali.
Ciò premesso e – spero – ben specificato, entro volentieri nel merito del cinema di genere Western e affermo che il Western del cinema pre-classico – del D. W. Griffith di Nascita di una nazione, per intenderci – sia stato un prodromo, un principio, seppure ideologicamente molto schierato, per molti versi anche razzista; tuttavia il genere Western di Griffith ha avuto gli indubbi meriti di nascita soprattutto delle tecniche, ad esempio di montaggio, quello analitico, laddove viceversa il grande regista russo S. M. Ejzenstejn adotterà quello analogico, anche detto montaggio delle attrazioni.
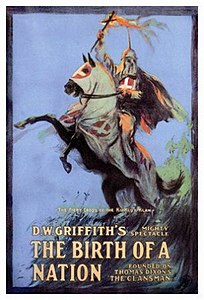
Il cinema classico di John Ford ha avuto ampi meriti: oltre a creare il genere Western p. d., ha conferito alla comunità dei personaggi – sia questa dei cowboy o dell’esercito o dei civili, anche e soprattutto delle donne, anziani e bambini, afferenti nei luoghi e negli spazi diegetici – il ruolo di reale protagonista delle vicende raccontate, pur lasciando all’eroe di turno l’apparente spazio di primo piano.

Ma è nei ’60 che si attua il punto nodale di svolta del genere Western. Il nostro Sergio Leone, con le sue due trilogie, quella del dollaro e poi quella del tempo, donerà al genere tanto la connotazione poetico-epica – Il buono, il brutto e il cattivo – quanto quella elegiaca – C’era una volta il West.

Sarà tuttavia Arthur Penn a realizzare, in quegli anni, probabilmente il massimo capolavoro della storia del cinema Western con il suo The little big man, nel quale l’espressionismo (“Andate laggiù se avete coraggio“), l’elegia (“… finché l’erba cresce, il vento soffia e il cielo è blu“) e il resoconto storico (“Mi chiamo Jack Crabb e sono l’unico sopravvissuto bianco al massacro del Little Big Horn“) sui nativi d’America si integrano finalmente in un meraviglioso asciutto connubio, maturo e scevro degli orpelli manieristici del cinema americano precedente, per rappresentare l’eterno atemporale contrasto fra i Jack Crabb mulattieri e gli esaltati maniacali generali Custer, di ogni ordine ed epoca (quanto, qui, dei più semplici e tradizionalli uomini o caporali del nostrano Totò?)

Non ultimo, in The little big man, gli ampi spazi della frontiera vengono rappresentati in maniera coerente con le esigenze sociali e culturali dello scorcio finale dei ’60; ci si potrebbe chiedere, in termini di spazi infiniti, quali siano le differenze fra questo capolavoro e l’Easy Rider di Dennis Hopper e/o il Nashville di Robert Altman, dove in quest’ultimo, tra le altre cose, spicca quel suadente e accattivante evergreen di I’m easy, di Keith Carradine, figlio d’arte di quel John Carradine, già icona e giocatore d’azzardo dello Stagecoach (Ombre rosse) di John Ford.

Emozionante e sontuoso sarà anche l’affresco che, sempre sui nativi d’America, qualche decennio dopo realizzerà Kevin Costner con il suo Dances with wolves, sulla scorta di una magnifica fotografia e ancor più di una tra le più belle e ariose (!!!) colonne sonore, di John Barry, mai scritte. Tuttavia questo capolavoro di Costner sarà indiscutibilmente debitore per molte cose, non ultima la comunque indubbiamente genuina ispirazione, nei confronti del capolavoro di Arthur Penn.

Mutatis mutandis, uscendo adesso dal genere filmico fissato all’inizio e volutamente cambiandolo/ampliandolo, tutto quanto detto fino a qui è vero analogamente a come La grande bellezza di Paolo Sorrentino nel 2013 sarà debitore al felliniano Otto e mezzo del 1963: epoche e società diverse, tuttavia – per chi sa leggere e ben guardare – medesime ispirazioni e tematiche.

In merito alle tematiche va infine detto che – nel Grande Cinema, come in tutte le forme di Grande Arte – queste travalicano il genere e l’immediato contesto, universalizzandosi: analogamente a come ebbe da dire il nostro regista Franco Brusati in merito al suo Pane e cioccolata, il quale non era da leggere e da intendere “semplicemente” come un film sull’emigrante quanto, piuttosto, come un film sull’uomo solo.

In modo analogo, The little big man non è solo un film Western ma un più ampio apologo sul fanatismo umano e sull’umiltà dei singoli, sulle stragi dei popoli e sulle ceneri della Storia, il tutto filtrato dallo sguardo di un grande autore e, solo accidentalmente, sullo sfondo dell’epopea della frontiera.
Sono, questi, spazi sempiterni in perenne coniugazione e nesso con le saghe di tutti i luoghi ed epoche: da quelle omeriche a quelle fantascientifiche ma emblematiche di un Blade Runner o, ancora, a quelle tolstoiane di Guerra e Pace; essi, sempre, parlano a noi una lingua universale ed eterna.
[Fabio Sommella, 24-27 aprile 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
Volendo da subito smorzare l’inclemente e provocatoria forza del titolo – Cattiva, romanzo di Rossella Milone, edito da Einaudi nel 2018 – va detto che il personaggio di Emilia, istanza narrante nonché protagonista, non risulta propriamente cattiva quanto, più verosimilmente, solo profondamente umana.
Emilia è una comune trentenne, sufficientemente acculturata che – emerge, col procedere della narrazione – per professione conduce i turisti a scoprire le bellezze dei siti archeologici dell’hinterland napoletano. Quest’ultimo, come tutta la vicenda a cui la protagonista dà voce in prima persona, è descritto con toni sempre asciutti ed essenziali, con un linguaggio quotidiano che conferisce allo stile della narratrice proprio i suoi peculiari colori, struggenti, financo lirici.
Ma Emilia, come quasi tutte le giovani donne, è da subito pure una sorta di trasecolata novizia rispetto all’esperienza della gravidanza, del parto e della maternità, del prima, del durante e del dopo; esperienza questa sì vissuta e raccontata in modo forte, estremo, efferato… ma in fondo così naturale, come l’arte primitiva della sopravvivenza. Ed è forse proprio grazie a questa indicata sorta di noviziato che il breve romanzo – in termini di asciuttezza ed essenzialità di stile, pur nella grande diversità di vicenda e ambientazione – riecheggia e richiama le esperienze umane di Ida, 2013, film di Paweł Pawlikowski.
Tutta la storia di Emilia viene narrata secondo tre assi direzionali: il prima lontano, pertinente al pregresso di Emilia e della sua famiglia; il prima immediato, pertinente al parto; il dopo, pertinente ai primi tempi della maternità. Ciò avviene in un continuo caleidoscopico ribaltamento dei piani temporali, continui salti, inserti e spaccati di vita che, a tratti, possono far ricordare quelli ultradecennali dell’Underworld di Don DeLillo. Senza però la pretesa dei vertiginosi scambi narrativi epocali operati dallo scrittore americano, in Cattiva le vicende della coscienza della protagonista, percorrendo questi tre assi, si approssimano progressivamente al punto di convergenza: il parto propriamente detto. Questo si scinde poi in due attimi: il durante – notevolmente dilatato, in un tempo di coscienza bergsoniano che apre alle infinite sollecitazioni dell’esistenza, del dolore, della Storia – e l’immediato dopo, con finalmente serene e rasserenanti immaginette familiari. È qui che si ha un climax, un acme, la coscienza del momento di nascita altrui – prole – e rinascita di sé stessi – Emilia, il marito Vincenzo… – e del conoscere ciò che, in precedenza, per molti versi era ancora indistinto da sé.
In questo narrare, la costante è sempre la splendida voce autoriale di Rossella Milone, voce di cui solo i grandi scrittori possono disporre. L’autrice disegna immagini evocative di estremo impatto e rara intensità, pur nella loro apparente consuetudine; situazioni universali eppur nuove che lasciano scoprire altro al lettore, quasi anch’egli fosse un turista dei siti archeologici dell’hinterland napoletano. Perché, analogamente a quanto avviene in molti film di Tarantino, la Milone è in grado di raccogliere un ordinario e apparentemente ininfluente dettaglio quotidiano e allargarlo, ampliarlo e sviscerarlo, ricreando o ricuperando, da quel grumo iniziale, un mondo di significati sottaciuti, inespressi, perduti nell’alveo del comune vivere. Non ultima, il lettore avverte affiorare la propria, e quella dei propri affetti, più intima esperienza, la coscienza, biologica e cerebrale, della trasformazione che la gravidanza e la maternità imprimono alle nostre vite.
Attraverso la vividezza di tutti i personaggi – Emilia stessa, il marito Vincenzo, il fratello Daniele, la madre e il padre, la vicina signora Gargiulo, la vaiassa ostetrica Ilaria, il restante personale ospedaliero, la salumiera, i barboni… la nascitura Lucia – noi lettori, si sia madri o padri o figli (ciò non importa), usciamo dall’esperienza di lettura di Cattiva con la consapevolezza – mediata dalla soggettiva prosa narrativa e non dalla oggettiva semplice embriologia – del mutamento che, l’infinità di quegli attimi di parto, provocano irreversibilmente sulle nostre coscienze e identità: ciò che prima era unità e dipendenza, pur sempre più duplice nel suo itinere, diviene infine duplicità piena e autonomia in fieri: “In quel tocco c’era la compiutezza né di me né di lei, ma di un noi, ché io e lei già eravamo due cose diverse, due persone diverse che stavano per conoscersi.” [pp. 87-88]
A latere, il romanzo è anche un’esortazione – quanto sommessa? – a una fiducia decisamente non cattiva bensì umana: “Mia figlia deve sapere che noi siamo quello, che noi siamo uno dentro l’altra, e lei è già sola, come lo sono io con lei, come lo è Vincenzo con me, ma ci sono modi, a volte, ci sono i mezzi per entrare nelle persone e non restare soli.” [p. 67]
Il progetto di arrivo e ripartenza, di cui tutto il romanzo Cattiva è intimamente intriso, coagula nelle parole che quasi concludono il romanzo: “L’espressione che ha Lucia ora non è né mia né di Vincenzo, e questa cosa solo sua è una profezia. È da qui che posso ripartire, da questa immensità. Dalle cose solo sue che devo scoprire per poi farle rimanere solo sue.” [p. 92] È proprio in questo auspicato e ricercato senso d’immensità che anche il lettore, che ha accompagnato Emilia nel suo travaglio e nelle sue peregrinazioni, può e deve avere fiducia: nei “mezzi per entrare nelle persone e non restare soli.”
[Fabio Sommella, 12-14 aprile 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
E
come i violinisti del Titanic
suonar
nel tuo pensiero i
Mille giorni di te e di me
mentre tutto intorno
procede alla deriva.
[Fabio, 5 aprile 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
Un gustoso, garbato, umoristico e assennato ritratto di una trasformazione: quella pertinente all’«uomo che non deve chiedere mai». Tutto scritto in una intrigante prima persona, se le vicende iniziali del protagonista nascono, salgono crescendo fino a risultare – volutamente – ossessive e financo stucchevoli, quelle successive interrompono al momento giusto le prime per dare spazio a un riemergente senso di umanità e tenerezza, a un’arguzia e a un’autoironica introspezione che allargano l’orizzonte e la scena liberandoli da quella claustrofobia che stringevano nell’asfissia il lettore nei primi capitoli. L’eco del racconto filmico Quando eravamo repressi, 1992, di Pino Quartullo sovviene inevitabile al lettore che ha amato quel tipo di agrodolce ironia sulle ferite auto-inferte ai sentimenti. Complimenti a Sam Stoner – che certamente non ha bisogno di quelli di chi scrive queste righe – per una splendida prova d’autore, sempre in bilico fra buongusto e ricerca dell’effetto dissacrante di un certo tipo di costume, diversa da quella pure magistrale di “Elvis Rosso Sangue”, nella quale però gli eccessi splatter e le tinte forti erano – anche qui, volutamente – estremi fino al parossismo. Pur sfondando una porta aperta, piace ribadire che Sam Stoner è indubbiamente equipaggiato delle necessarie doti narrative e stilistiche tanto per i noir e thriller che per gli arguti e brillanti ritratti psico-culturali di genere. Da leggere, irritandosi nelle prime pagine, intenerendosi nelle ultime. 😊
Vetrina: https://www.amazon.it/Lamore-questo-bastardo-Sam-Stoner-ebook/dp/B00RGYDX8Y
Posted anche su FB al link https://www.facebook.com/PierreBezuchov0 in data 04APR2019

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
Toccanti testimonianze (fare clic sulla foto). Ringraziando gli amici Dario Amadei ed Elena Sbaraglia, del Magic BlueRay, ho preso in prestito la loro bella foto perché esemplificativa di cosa e come.
Come sospeso tra una dimensione espressamente scientifica e una, viceversa, manifestamente umoristica – riecheggiante, sul primo versante, il Musicofilia di Oliver Sacks mentre, sul secondo, (qualcuno lo ricorderà?) il Carugati di Gino Bramieri (!?!) – Amore e altre psicopatologie (Desmond Avenarius, editore Graphofeel, 2018) si presenta come una simpatica prova d’autore di genere narrativo-saggistico-comico-grottesco. L’epigrafe di premessa, ripresa da Arthur Schopenhauer e riferita all’amore inappagato per Laura da parte di Francesco Petrarca, già annuncia l’impianto eminentemente biologistico-naturalistico che sorregge l’intera opera, a discapito di qualsiasi possibile sovrastruttura astratta e metafisica.
La prima e più voluminosa parte si articola in una serrata sequela di fantasiosi e gustosi casi clinici. Tema: la psicopatologia dell’amore. Ma in tutto il libro, all’interno di una folta galleria di annotazioni aneddotiche, se ne riconoscono e memorizzano alcune davvero esilaranti: il Giannino alias Lupo e la Pina alias Cappuccetto Rosso; l’acquisita maturità sessuale d’un protagonista in concomitanza della storica Italia-Germania 4 a 3 del ‘70; il “Sesso con piacere” della tribù amazzonica degli Zanduka (?!?!), per molti versi riecheggiante da una parte il “Sesso senza amore” di un’altra tribù, quella televisiva di Dandini/Guzzanti di qualche anno fa, dall’altra il Bunga Bunga di un premier, pure di qualche anno fa.
È in questo modo che prendono corpo una serie di storie, vicende, immagini dense e ricche di colore, iperboliche, paradossali, anche surreali. La galleria umana, spesso goliardicamente estrema, non escludente pur lontani echi boccacciani-boccacceschi del filone commedia filmica italiana ’60-‘70, talvolta volutamente financo mandrillesca, non oltrepassa mai i limiti del buon gusto. Il lettore risponde al simpatico strizzar d’occhio degli autori e viene sapientemente condotto fra tragiche disavventure di traumi affettivo-amorosi e galanti avventure sentimentali. Tutti gli avvenimenti iniziali degenerano inevitabilmente in dolori dell’anima; ma, proprio grazie al professor Desmond Avenarius, tutto viene sempre risolto, puntualmente. Altrimenti non ci sarebbe necessità del suo intervento, analogamente a quanto avviene nella fiction Don Matteo, in cui è richiesta la redenzione, altrimenti non ci sarebbe necessità del sagace ed evergreen sacerdote. Pertanto, anche qui, avviene sempre la guarigione dei pazienti, tanto di quelli cronicizzati, quanto di quelli vittime delle fasi acute della psicopatologia denominata Amore.
Le mirabolanti vicissitudini, ovviamente, vogliono essere e sono l’autentico punto di attrazione del libro in cui. all’interno di una dimensione narrativa affabulatorio-fantapsicologica, si concede largo spazio all’ironia e alla satira dei costumi umani. Ma l’epicentro e fil rouge, il punto di inevitabile arrivo, è il meta-magico-scientistico elettroerototropion. Quest’ultimo strumento centrale, sorta di black box (della sua costituzione ne viene fornita una sommaria descrizione in Appendice), dati degli elementi in ingresso (la psiche del paziente), è in grado di discernere e chiarire le cause dei dolori dell’anima, generando di volta in volta in uscita delle risposte diagnostico-terapeutiche. Queste sono inequivocabili, fondantisi sulla scienza dell’erototropiologia umana applicata, disciplina appunto fondata dal professor Desmond Avenarius di Trockenerhugell. Il lettore medio, erroneamente, potrebbe ritenere questa disciplina in qualche misura imparentata con la tropologia, ma certo in merito il prof. Desmond Avenarius sarà in disaccordo.
Nell’Appendice, infine, sono ricostituite, con indubbia verosimiglianza parascientifica, le basi teoriche che fanno da supporto alle dottrine del professor Avenarius: attraversando canoni e criteri di psicologia dell’inconscio, modelli antropologici ed etologici, criteri estetici di narratologia con finalità “biblioterapeutiche”, il lettore viene guidato a esplorare i capisaldi della erototropiologia. In particolare, toccando l’area della biblioterapia, viene adombrata l’ampia questione pertinente tanto alle modalità di fruizione delle storie raccontate quanto, ancor più importante, allo scrivere storie. È qui che, con un furore alla Savonarola, il professor Desmond Avenarius – o chi per lui – si scaglia e prende posizione in merito al proibire alcune storie, almeno in certe modalità (“libri che secondo me dovrebbero essere condannati alle fiamme senza pensarci un attimo”).
In ogni caso la fascinazione è assicurata, perché i capisaldi dell’erototropiologia umana applicata, partoriti dalla feconda mente dell’illustre neuroscienziato, al di là della dimensione finzionale saggistico-narrativa, divengono mete ideali e approcci di vita, richiamando – ancora una volta, perché no? – una rediviva Età dell’Oro (vagheggiata quasi sessanta anni fa anche da Luciano Bianciardi in chiusura della sua Vita agra), il desiderio di ritornare a uno stato di natura virginale che – superfluo dirlo – è perduto alle nostre latitudini e nella nostra civiltà. Luogo comune? Forse. Ma il lettore chiude il libro persuaso di trovarsi di fronte a un nuovo dominio di conoscenze sulla natura e psiche umana in cui la buona narrativa e narratologia assurgono a fondamenti. Chissà se l’erototropiologia sia il connubio di biblioterapia e musicoterapia medesime? In ogni caso non si può fare a meno di tessere simpaticamente le lodi del professor Desmond Avenarius e dei suoi fedeli collaboratori Dario Amadei ed Elena Sbaraglia.
[Fabio Sommella, 27 marzo 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
Mi sento solo, come ai miei dieci anni, o giù di lì. Allora erano le estati. Mio fratello era già fuori. Io ero in casa con mia madre. La finestra della stanza aperta (era estate!) Io, seduto sulla poltrona, quella di fianco al mobil letto. Mi rivedo: sto leggendo – ormai ho imparato, e non faccio più “tsktsk…”, come quando più piccolo guardavo le figure dei Topolini, fingendo di leggere quasi in codice Morse – sì; sto leggendo dei Tex, quelli a strisce da cinquanta lire, col cartoncino più spesso sul lato sinistro… come dire? “Rilegati”, e non con le crappette sempre sul lato sinistro, perché quelli erano i fascicoletti da trenta lire, di appena qualche anno prima.
Quindi sto leggendo Tex: è l’avventura importante contro Mefisto… sì, certo, contro Mefisto ce ne sono state già due, forse tre: ma questa è quando Mefisto si allea poi con il Baron Samedi e un gigantesco nero – di nome Dambo? – in Florida, a Tampa… insomma, stabilisce un’alleanza con un folle, scappato da un manicomio – ne abbiamo, adesso, anche qui, tra i personaggi pubblici? – e decide di sollevare la nazione Nera. Ci sono una miriade di neri, coperti da pelli di leopardo, che si muovono sinuosi e insidiosi lungo le acque della Savana dove, dice uno dei titoli, corre il Terrore. E loro due – Mefisto e Samedi – vivono in un castello di stampo medievale, nel cuore della Savana, da cui con un potente organo a canne, nei momenti di crisi mentale (!?!) di entrambi, o forse solo di uno di loro, s’irradiano tetre musiche in tutto lo sterminato aere circostante, in quel territorio, tra gli alberi, tra gli arbusti, fra i torrenti, i rivi, le vegetazioni, fino ai cieli della Florida.
Galep e Bonelli, sicuramente, diedero del loro meglio in quella sontuosa avventura che occupò, se non sbaglio, tra i quindici e i venti fascicoli da cinquanta lire.
Naturalmente Tex e Kit Carson – forse anche Kit Willer e Tiger Jack – sono chiamati ad affiancare le autorità militari del posto per sgominare la pericolosa congrega criminale di Mefisto, Samedi e compagnia.
Mi sento solo – adesso – come allora: allora ero su quella poltrona, a leggere queste storie, colorite, colorate seppure bianco e nero – era il ’68 – e trascorrevo le mattine attendendo chissà cosa: mio padre dal lavoro? Mio fratello dal mare? Il mio mare? Il trasferimento nella nuova casa, fuori, ai Castelli? – Romani, non Medievali! – Che tornasse ottobre? La crescita? Nuovi amici?
Intanto fuori era il Maggio, o era appena passato. File infinite di giovani variopinti popolavano le strade di Roma, in una promessa di protesta, d’amore, di gioia. Io avevo appena compiuto la Prima Comunione, insieme ai miei amici e amiche di Scuola da cinque sei anni – amici dai tempi dell’Asilo – che però non avrei più rivisto, perché, di lì a breve, avremmo cambiato casa, zona, quartiere. Quindi: nuovi amici, nuove scuole, nuove zone.
E cantavano le canzoni del tempo…
Mi sento solo – adesso – come allora. In ferie dall’annoso lavoro aziendale – cerco di riscattarmi facendo tante altre cose – mio figlio fuori all’UNI e poi, in serata, ai cinema-teatro di Roma – l’Adriano? Memorie di Beatles… – mia moglie, ormai, via da quel dì… i nuovi amori, lontani tutti… i cari amici, sentiti, spesso, ma non bastano, non riempiono, non saturano… guardo all’arco degli anni, dei decenni – tanti, troppi – trascorsi e… allibisco. Un cuore, una mente, da eterno ragazzo e un corpo e un’anagrafica – come ha detto stamane un carissimo amico per entrambi noi – da gerontocomio… inciampi in anomali scalini di bus-navetta, urti contro reti stradali invisibili ai tuoi occhi, ti scontri (!?!) contro pali stradali alla sera… passino pure i dislivelli o i marciapiedi non visti… ma che è?
E sembra allora che non sia passato poi tanto tempo… o che tutto il tempo passato, insieme ai suoi tanti eventi, ai trenta, quaranta, cinquanta anni – siano così… relativi, fatui, inutili – eh, certo, no, non del tutto, è? – sommari, tenui, scomparsi, imprevedibili, invisibili…
Così ti adagi in una nuova sorta di poltrona: attendi l’estate? Il mare? Tuo figlio? Un qualche recondito evento che ti faccia sentire… sentire vivo?
Nel frattempo ti raccomandi a Tex e ai suoi fedeli pards: non sparate, non sparate con l’artiglieria pesante: Mefisto e Samedi e Dambo sono anch’io, perché siamo tutti dei buoni amici, in definitiva… e, quello che corre sulla Savana, non è Terrore… è solo Vita!

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)