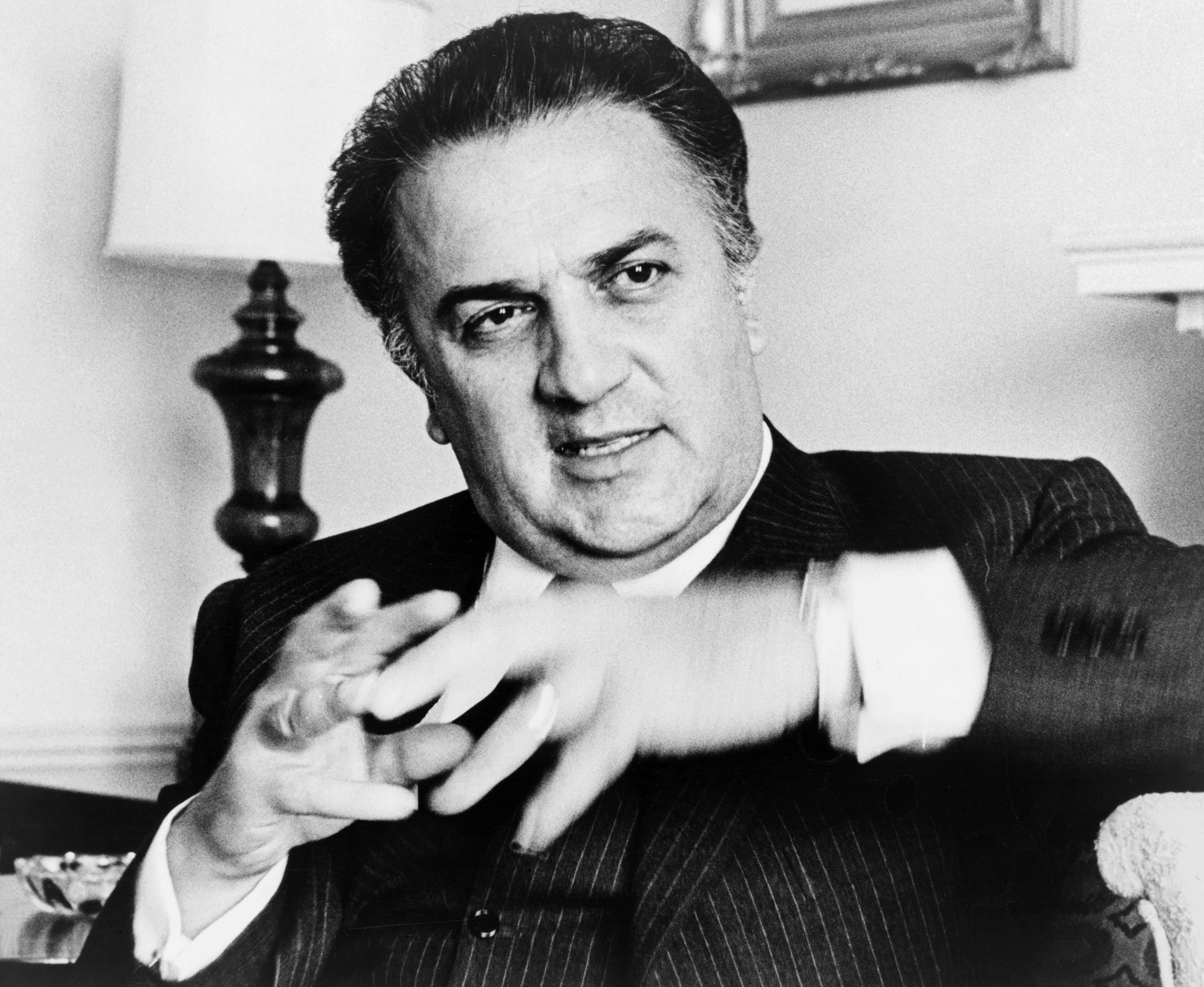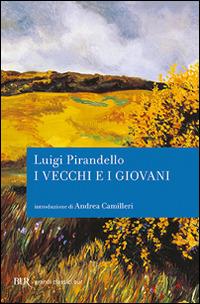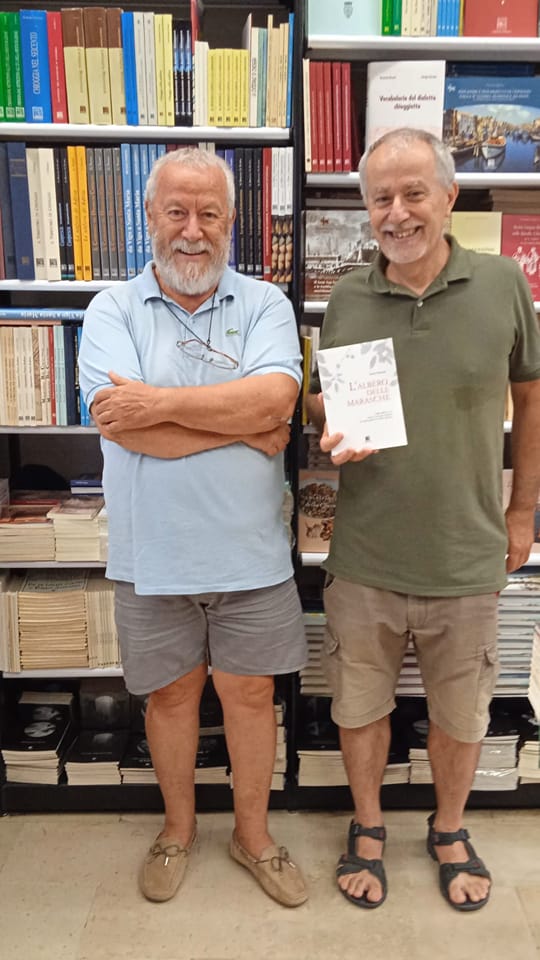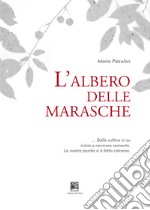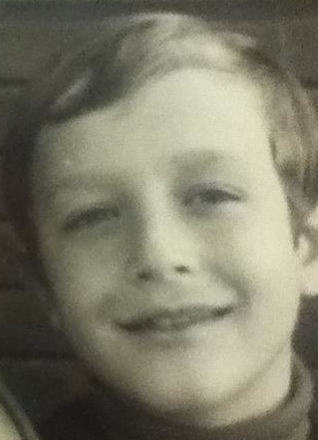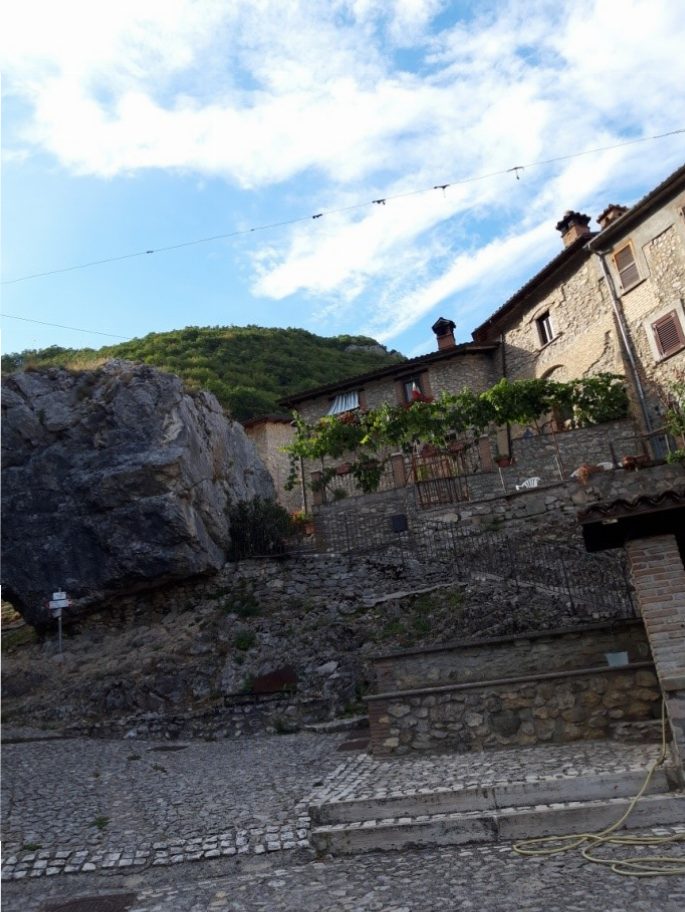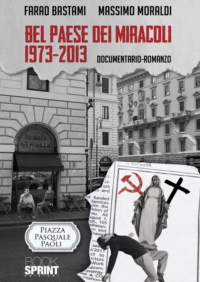Apro la finestra, è primavera. Tornato il caldo faccio entrare l’aria del mattino, ma anche i suoni del traffico, certo, nonché il frequente cicalino dei semafori, al crocevia sotto casa. L’attivazione del cicalino, l’avvisatore acustico, necessita giustamente ai non-vedenti. Ma da anni mi chiedo: perché viene premuto con tale frequenza, aumentando il rumore della città? Quanti non vedenti ci sono che attraversano ai semafori? La gente normale pensa che così il semaforo diventi verde prima?

Giro nel quartiere. Ormai ci siamo abituati ai monopattini fermi sui marciapiedi, abbandonati nel bel mezzo del passaggio. Il guaio è quando sfrecciano sui medesimi, come pure alcune biciclette. Il marciapiede è divenuto una pista ciclabile? Provate a dirlo e a fare le rimostranze a qualcuno dei suddetti: va bene se ti porgono le scuse o se non rispondono male.
Autovetture parcheggiate sulle strisce pedonali, qui al VII Municipio, sono frequentissime, perfino in prossimità dei semafori. A Largo dei Colli Albani devo attraversare e il semaforo di fronte è completamente occluso da un furgone, collocato proprio sulle strisce; essendo alto impedisce di vedere se il semaforo per i pedoni è verde. Guardo sopra di me e comunque comprendo dai pedoni che, aggirato il furgone, attraversano nella mia direzione. Così attraverso anch’io. Passo, aggirandolo anch’io, vicino al furgone che è chiuso posteriormente ma sul fianco, lato marciapiede, un giovanotto sta armeggiando con un portellone aperto, incurante (fregandosene) di me e degli altri passanti. Provo a immedesimarmi in lui: penso che svolge un lavoro forse ingrato e che, certo, nel quartiere è difficile trovare un punto di “scarico merci” adeguato, Così tiro dritto e raggiungo un negozio poco più avanti. Sbrigo la mia commissione e torno sui miei passi. Sono passati dieci minuti e il furgone è sempre lì, a occludere il semaforo e l’attraversamento pedonale, col giovanotto che adesso sta scaricando con un carrello del materiale dal retro del furgone. Cinque metri prima ho notato un ampio parcheggio libero. Mi avvicino al giovanotto dicendogli: “Perché non ti sposti cinque metri in là, dove c’è uno splendido parcheggio libero, con cui non occluderesti il semaforo e il passaggio?” “Ah capo, quanno so’ venuto nun c’era e nun ci’ho tempo…”, quindi bofonchia qualche altra cosa, continuando a fare il suo comodo. Me ne vado, applaudendolo e gridandogli “Bravo!”
Entro nel supermercato e seleziono un carrello che non abbia i guanti di plastica abbandonati, lì dentro, dai precedenti avventori. Volete, per igiene giustamente, non toccare le merci della frutteria a mani nude? Bene: usate i guanti di plastica ma, dopo l’uso, perché li abbandonate nel carrello? Questo è igienico? Perché non li gettate negli appositi cestini?
Scendo al Metrò di Colli Albani. Non c’è scala mobile, essendo il dislivello in effetti minimo. Mi appoggio alla balaustra però, perché non vedo bene i gradini: perché non aumentano l’illuminazione, che è davvero scarsa? Sono anni che è così. Rammento che, anni fa, dopo una mia lamentela al personale lì presente, posero il mancorrente in mezzo all’ampia scala che precede i binari del treno. Ma, adesso, la stazione risulta sempre priva di sorveglianza. Non scorgo mai nessuno a qualsiasi orario si passi. Tuttavia, mentre con la tessera supero il tornello, intravedo un ragazzetto che tira dritto verso i passaggi di uscita, li scavalca ed entra verso i binari del Metrò, probabilmente, senza aver pagato il biglietto. Penso all’azienda municipale di trasporto, che dicono sempre in crisi economica, e mi chiedo: perché quel ragazzetto ruba? Certo: c’è la crisi. E allora tutto è lecito?
Rifletto tra me che il quartiere è completamente lasciato all’incuria e ai capricci di ciascuno che abbia desiderio di fare il proprio porco comodo. Penso anche che, a vent’anni, non avrei notato tutto ciò o l’avrei risolto con una scrollata di spalle Ma non voglio i vigili, le guardie, i poliziotti che dicano a ogni cittadino ciò che deve e non deve fare: perché credo nelle scelte autonome di ciascuno di noi nel rispetto degli altri. Ho ancora fiducia nell’uomo, nella sua autonomia, nella sua forza anarchica che non significa fare scelte di comodo ma fare scelte responsabili per tutti. “Perché la coscienza non s’insegna”, cantava quel cantautore trasteverino.
Sbaglio.
Me ne vado con il fagotto delle mie domande: perché, il cicalino, viene premuto con tale frequenza, aumentando il rumore e la nevrosi della città? Il marciapiede è divenuto una pista ciclabile? Perché, tu lavoratore certo, non sposti il furgone cinque metri in là, dove c’è uno splendido parcheggio libero, senza occludere il semaforo e il passaggio? Non te ne frega che puoi mettere in difficoltà le persone? Perché abbandonate i guanti di plastica usati nel carrello? Perché non li gettate negli appositi cestini? Perché non aumentano l’illuminazione, sopra le scale NON mobili, quando è davvero scarsa? Perché quel ragazzetto ruba?
Perché tutto è lecito?
[Fabio Sommella, 29 aprile 2024]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)