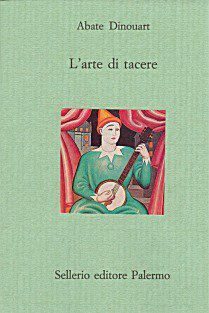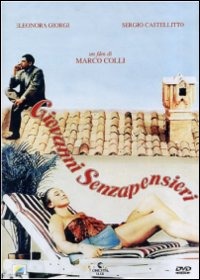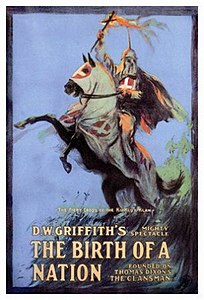Serenity – L’isola dell’inganno, 2019, di Steven Knight solo in apparenza si propone come un tradizionale thriller dalle connotazioni torbide e inquietanti, essendo esso un intelligente esempio su come i riferimenti alle tecnologie della contemporaneità – scrutati dal severo sguardo di un adolescente – possano rivisitare e rinforzare i canoni del noir. Senza indugiare oltremisura attorno a questa chiave di lettura, per ovviare a qualsiasi spoiler eventuale, si può e si deve dire che innumerevoli echi, cinematografici ma anche letterari, si possono cogliere nel corso della visione di questo film. Vediamoli un po’, in quanto forse il loro pur rapido esame ci fornisce una comprensione migliore in merito all’ispirazione e al significato di questo lavoro di Knight.
In primis torna alla mente il torbido intreccio de Il postino suona sempre due volte, 1981, di Bob Rafelson, laddove si racconta di una coppia, nuova o vecchia che sia, che escogita un piano: eliminare un terzo incomodo, pacifico o violento che sia. Ma ciò appare solo l’inizio.
L’ambientazione – pescatori di giganteschi tonni e pesci spada al largo di Miami e Cuba, i loro ostentati ritratti fotografici assieme al frutto della loro bramata fatica – rimanda potentemente a quel piccolo/grande capolavoro letterario di Hemingway, Il vecchio e il mare. Ma anche ciò è solo la premessa iniziale.
La non infrequente voce fuori campo, sorta di seconda istanza narrante radiofonica in cui un redivivo lupo solitario scandisce le fasi della giornata a Plymouth, località (fittizia?) in cui si svolge l’azione, riecheggia in modo deciso American Graffiti, 1973, di George Lucas.
Il rapporto fra il protagonista e un suo collaboratore di colore (l’attore Djimon Hounsou), per molti versi nei modi riecheggia quello fra Robin Hood e il suo attendente arabo (l’attore Morgan Freeman) in Robin Hood – Principe dei ladri, 1991, di Kevin Reynolds.
Ma certamente più ghiotti e numerosi divengono gli echi quando, in questo film di Knight, agli occhi dello spettatore comincia a emergere il gioco – ben orchestrato dal regista – fra vita e artefatto, tra realtà e finzione, fra dentro e fuori, fra creatore e creatura, fra regole previste e agognato cambiamento delle medesime. E qui molteplici, pur nelle differenze delle portate dei film, sono le reminiscenze: da Tron, 1982, di Steven Lisberger, a Blade Runner, 1982, di Ridley Scott, da Nirvana, 1997, di Gabriel Salvatores a Matrix, 1999, di Lana e Lilly Wachowski, ma anche al precedente Una pura formalità, 1994, di Giuseppe Tornatore. È l’eterno gioco fra veridicità e camuffamento che, in forme cangianti, si perpetua all’interno delle narrazioni. Perché? Ma perché, probabilmente, esso – tale gioco – è il sale dell’esistenza che ne racchiude i più riposti significati.
Quindi Serenity – L’isola dell’inganno, oltre alle specificità proprie, è anche tutto ciò: un coagulo di temi pregressi, di trame precostituite; il tutto calato nei modi della incipiente galoppante mutevole contemporaneità.
Film utile? Film necessario?
Non sappiamo.
Ma, di certo, a fianco a tanti lamenti auto-celebrativi o a pretesi apologi sul rapporto contemporaneità/tecnologie, il film di Knight , pur collocandosi all’interno di un alveo indubbiamente attento al fattore commerciale, brilla per: buon gusto espressivo, equilibrata conduzione, ben dosato rapporto fra preamboli narrativi e climax, bella fotografia di esotici scenari, misurato senso della nostalgia per un rapporto esistenziale equilibrato che travalichi le tante violenze della quotidianità; oltre che per le convincenti performance degli interpreti, tra cui brilla Matthew McConaughey che dà il suo volto e il suo fisico scolpito al protagonista, duro dal cuore tenero. E ciò non appare poco.
Da non dimenticare che Steven Knight è autore di quell’altro piccolo/grande capolavoro di intimismo ed esistenzialismo che è il suo Locke, 2013, racconto filmico in cui un unico personaggio, il solo fisicamente presente in scena, interpretato magistralmente da Tom Hardy, nello spazio di una notte rivede e si gioca tutta la propria vita, affettiva e professionale, aprendo a nuove impreviste eventualità, solo per esser sé stesso, solo per amore: e anche ciò, decisamente, non è poco!
Lode quindi a Steven Knight e all’apparato produttivo tutto per Serenity – L’isola dell’inganno, intenso noir post-moderno, sempre in bilico tra realtà, gioco e desiderio di una diversa realtà scrutata attraverso gli occhi di un adolescente: laddove, se non una rappresentazione – teatrale, filmica, virtuale, onirica – cosa altro, è l’esistenza?
[Fabio Sommella, 22 luglio 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)