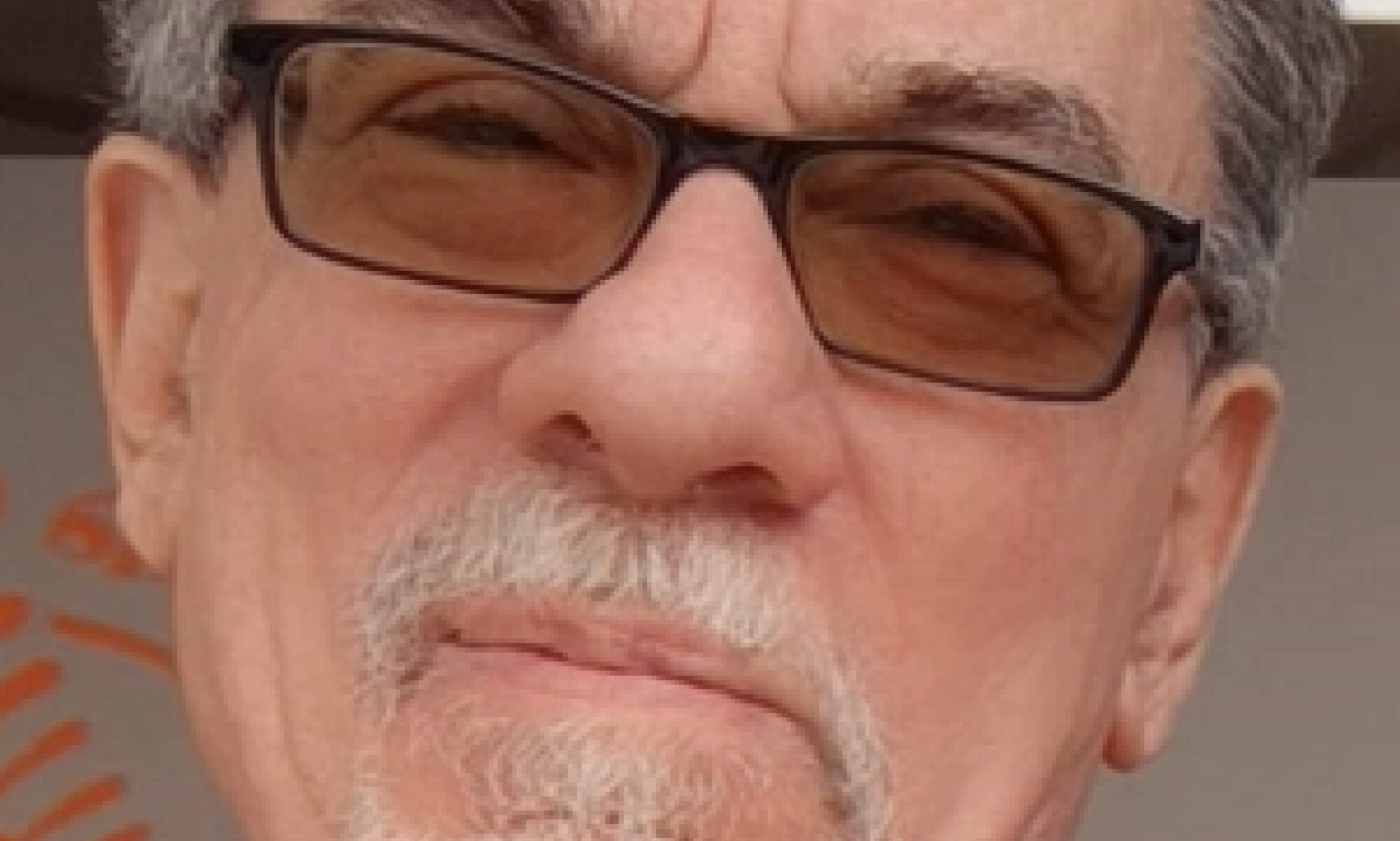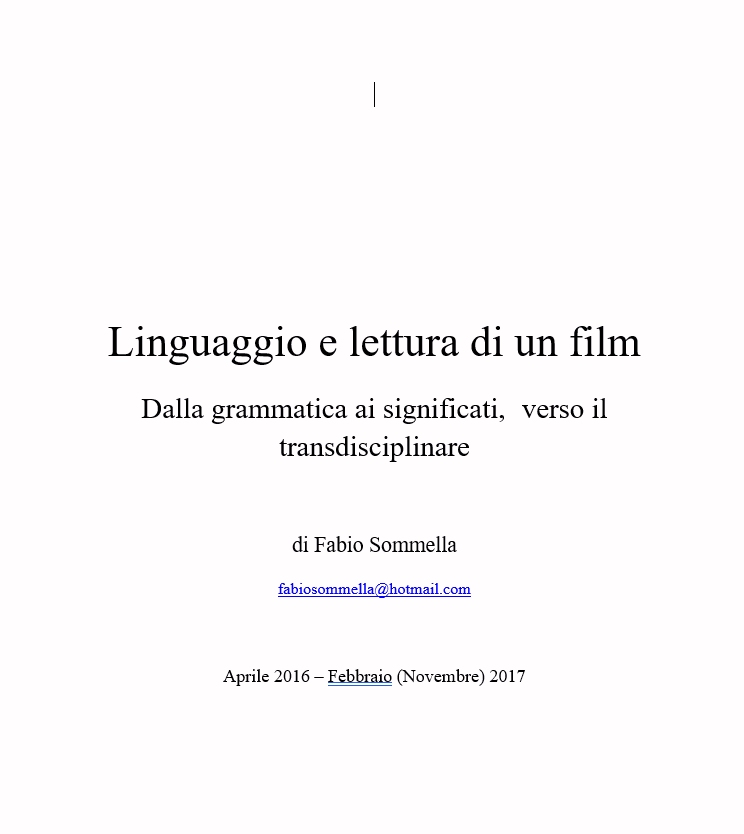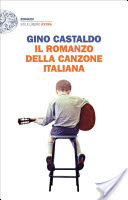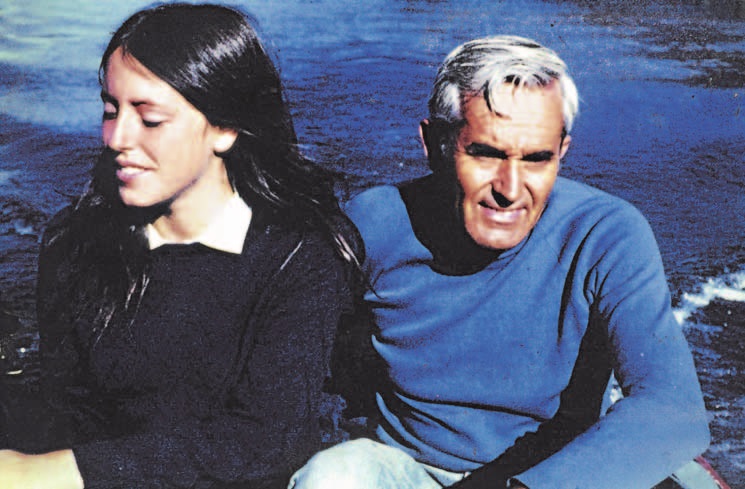Erano ormai anni, seppure non moltissimi (sei? otto?) – comunque dopo le nostre collaborazioni in Immagini e Parole e Immagini e Sonetti, queste databili al primo decennio del 2000 – che chiedevo all’amico Davide Cherubini (al secolo…, ma lo dice Lui nel libro) perché mai – tra le tante città del Mondo che lui aveva omaggiato attraverso la propria visione artistica – non avesse ancora realizzato un libro su Roma, che del resto è anche la sua città – ma anche questo, semmai, lo lascio specificare a lui – certamente di adozione, crescita affettiva, studio e lavoro, di amore/odio e quant’altro ancora.
Davide, puntualmente, mi rispondeva in maniera evasiva: com’erano le sue risposte? «Ma, Roma, è troppo complessa… Roma è troppo ricca… Roma è infinita…» e così via, con queste o con altre menate del genere.
Finalmente, Davide, ha ceduto. E forse – non posso escluderlo – con le mie provocazioni ho un po’ contribuito a solleticare la sua vanità d’artista e a fargli accettare la sfida. Fatto sta… ecco qui, nella consueta accuratissima veste grafica, il sontuoso risultato: ROMA AMOR.
È questo un superbo affresco corale – una visione felliniana del XXI? In effetti le radici di Davide sono tali che si potrebbe pensare… ophs, che ho detto? 😊 – di alcune delle più belle vedute della nostra – nel mio caso, sempre con amore/odio, è il caso di dirlo – Città Eterna. E la bellezza – nonché, per quanto mi riguarda, anche la commozione – affiora netta e inconfutabile allorché Davide indugia, ripetutamente e ritmicamente, con il proprio obiettivo – quale o quali, nello specifico, mai domandarlo all’artista in quanto è un aspetto tecnico, di banale dettaglio, che Colui lascia prontamente cadere con sussiego – su un medesimo particolare soggetto: che sia il Pantheon o Piazza di Spagna o altro… fa nulla!
Come un volto di donna cangiante in momenti fuggevoli – che si glorifica d’immensità eterea o di attimi voluttuosi, che s’adombra di cupidigia o s’illumina di solenne magnanimità, che s’inorgoglisce di spocchia aristocratica o s’altera di fierezza plebea, che si compiace di sé o recalcitra riluttante – ROMA – sacra e profana, santa e meretrice, predicatrice e blasfema, aulica e triviale – emerge ogni volta come AMOR – al contempo tanto puro che contaminato – nei colori, luci, ombre rivivificati dall’occhio di Davide e viene restituita al lettore/osservatore come pura – questa si – pietas perennemente rinnovellantesi.
[Fabio Sommella, 21 dicembre 2018]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)