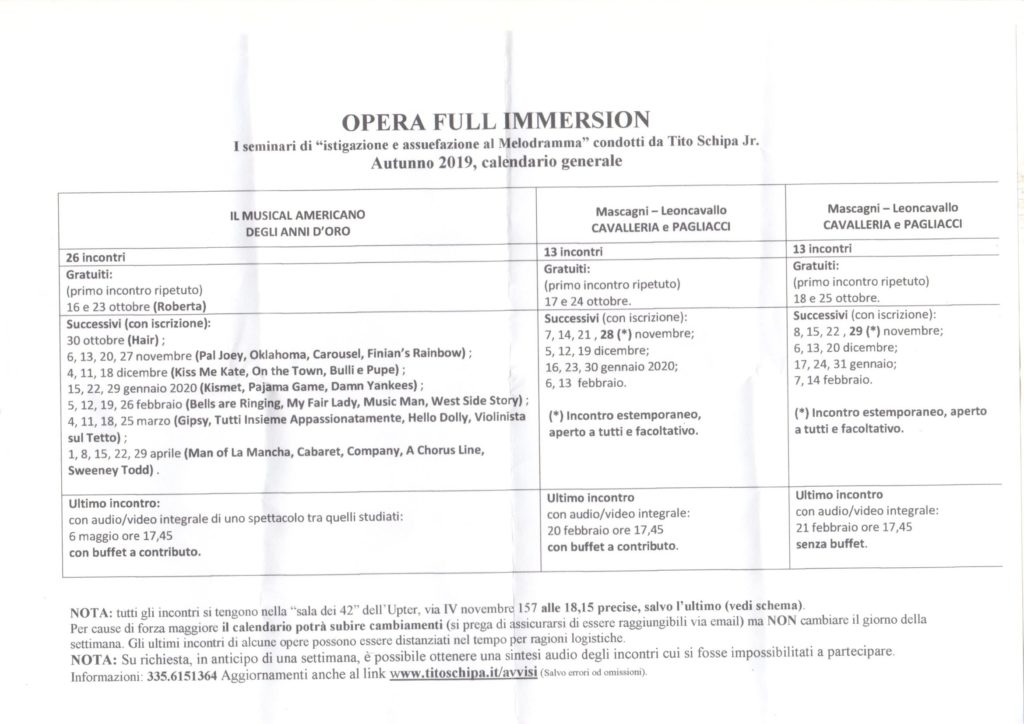Un trentennio dopo Mignon è partita, 1988, Francesca Archibugi torna, o prosegue, a parlare della famiglia con Vivere, 2019. Dal film che, secondo chi scrive, sanciva la chiusura – il termine, nelle coscienze collettive – del ventennio socio-culturale al femminile, si giunge a un altro film dove una frase emblematica – che dà il titolo a questa recensione – di uno dei protagonisti – Luca/Adriano_Giannini – mostra in modo implicito tutti i crismi della contemporaneità, altrove ancora definibile postmodernità.
Perché si afferma ciò?
Perché il film in oggetto ha una duplice natura e identità. Nel suo nucleo centrale, nella sua coscienza epidermica, la storia di Susi/Micaela_Ramazzotti e il già citato Luca, si sviluppa in maniera tutto sommato ordinaria, in termini di sceneggiatura essendo al contempo tanto sommessa e consueta quanto caotica e chiassosa: questo è un ossimoro per affermare che, i due protagonisti, costituiscono una coppia a cui fanno capo e afferiscono un nugolo di altri personaggi, grandi e piccoli, locali e stranieri, maggiori e minori, che tutti insieme vanno a costituire la ormai sdoganata famiglia allargata, certo confusionaria ma anche generosa; tra nostrani medici in famiglia e ultradecennali serial di bellissimi d’oltreoceano, nella fiction di maggior o minor rango, siamo avvezzi a visionare storie similari che riecheggiano, o pretendono di riecheggiare, poco o tanto le nostre quotidianità.
È certo in tal senso che i personaggi dei due protagonisti risultano, per molti versi, abnormi: vediamoli con un certo dettaglio.
Susi, resa senz’altro molto bene da Micaela Ramazzotti, risulta tuttavia spesso troppo sopra le righe. Maschera popolare, in tal senso riecheggia da una parte l’iniziale Elide_Catenacci/Giovanna_Ralli del C’eravamo tanto amati, 1974, di Erttore Scola; dall’altra la Fortunata/Jasmine_Trinca del film omonimo, 2017, di Sergio Castellitto. Ciò a indicare, nel travagliato vivere del personaggio, maestra di danza e ginnastica per donne problematiche ed obese, una indubbia e forte volontà di creare e portare in evidenza l’eccesso, il controverso, lo scomodo, per molti aspetti l’invadente che, con il proprio caos e spontaneità, riempia lo schermo conferendogli colore, voci e suoni, disegni già di per sé la vicenda, si badi classica, che sia spumeggiante fino a sfiorare il becero.
Luca, viceversa, è l’opposto: sommesso, taciturno, solitario, introverso, solo, combattuto e fin troppo lacerato – in tal senso, un altro voluto eccesso – è un uomo di mezza età aspirante scrittore su testate e blog minori, che tenta e vorrebbe arrivare al largo pubblico di lettori. La sua figura, resa dal bravo Adriano Giannini – quanta somiglia al grande padre! -, è fin troppo banale e ordinaria.
Susi e Luca: due personaggi antitetici, volutamente abnormi, pur in modo differente.
Ma questo è solo il nucleo centrale, in quanto Francesca Archibugi, nella sua sensibilità autoriale che è la medesima dei tempi di Mignon è partita, a margine – a livello subliminale e postmodernista, affermiamolo di nuovo – dice, racconta, mostra tante altre cose. Ciò in quanto la chiave di lettura del film non sta nei due personaggi centrali – e ciò spiega, come affermato sopra, il loro essere abnormi – bensì in quelli di contorno, minori o solo superficialmente definibili e ritenuti tali.
I protagonisti a latere, quelli che viceversa sostengono e giustificano davvero la storia narrata, sono – pur accennati, appena citati, secondo la migliore tradizione del postmoderno non_detto – labili, in parte evanescenti, colti di sfuggita, sfiorati, volutamente quasi dimenticati, casuali, accidentali come molte presenze del nostro, appunto, quotidiano vivere. Sono loro che danno spessore e profondità alla storia. Vediamoli, in base alla loro ritenuta rilevanza.
Innanzitutto Mary_Ann/Roisin_O’Donovan, suadente quanto basta figura di giovane donna irlandese che, come una presenza testimone altra, si aggira – come una sorta di rediviva quanto emblematica Missione Tata – nel gruppo famigliare allargato di fisionomie e spiriti romani. Ha pretesa di curare? Di migliorare? Di mostrare le diversità e le loro spigolosità? Sì, forse, probabilmente anche ciò. Riecheggiando inevitabilmente il ruolo di Mignon – la straniera che, un trentennio fa, giunge a Roma e sconvolge gli equilibri, certo molto precari, pregressi – Mary Ann è l’elemento nuovo, tutto sommato anche ovvio, che però conduce la storia, è il nocchiero (come già Mignon), il fil-rouge di tutto il racconto attorno al quale, anche i due protagonisti, per amicizia o per amore non possono esimersi di fare perno. Elemento di profondità portante e centrale.
Poi c’è il facoltoso nonno, avvocato_De_Sanctis/Enrico_Montesano, austero, ineccepibile, dotto, latinista, sornione e misterioso. Elemento di profondità a latere e marginale, che conferisce però ulteriore spessore alla saga.
La piccola Lucilla/Elisa_Miccoli e il giovane Pierpaolo/Andrea_Calligari, rispettivamente deus-ex-machina del racconto canonico e accidentale promotore del cambiamento, con i suoi modi inizialmente beceri e triviali; essi portano e conducono il racconto tradizionale verso altri personaggi e modi, siano il vedovo_professor_Marinoni/Massimo_Ghini, siano la presa di coscienza e la nuova più matura visione – da parte di Pierpaolo – nei confronti del padre Luca. Di corredo a questi, è il personaggio di Azzurra/Valentina_Cervi, madre di Pierpaolo e figlia dell’avvocato De_Sanctis.
Ma quello centrale, tra i protagonisti a latere, che davvero supporta e giustifica, motivandola, tutta la vicenda, è il Perind/Marcello_Fonte, immediato limitrofo vicino di casa di Susi e Luca. Piccolo, occhialuto, minuto, connotato da un grigio aspetto esteriore impiegatizio in senso deteriore, quasi viscido – riecheggia L’amico di Famiglia, 2006, di Paolo Sorrentino – intuitivamente ragionieristico/computista – senza alcuna offesa per queste categorie professionali – è magistralmente reso e incarnato dal già dog man Marcello Fonte. E va detto che, in questo film, il personaggio di Perind ha la medesima valenza che, in Tutta colpa del paradiso, 1985, di Francesco Nuti, aveva il calabrone/moscone che tormentava il protagonista Romeo_Casamonica/Francesco_Nuti. Se Romeo, nella scena finale, schiacciava il moscone/calabrone sul vetro della telecamera, fissandola e fissandoci, rivelando così che quel moscone/calabrone siamo noi, ovvero noi medesimi spettatori, con il nostro implicito giudizio morale, nello stesso modo Perind, nella scena finale, rivela a Susi di averli sempre osservati, lei e la sua famiglia allargata, di averli sentiti, avvertiti nelle loro urla e liti, nei loro dialoghi, di averli in definitiva spiati nel loro imperfetto vivere. È, questa cosa, – vivere – certo ricca di eccessi ed esagerazioni, di errori e anche di aberrazioni, ma è una cosa che, a Perind, nel suo solitario effettivo perfezionismo, privo di qualsiasi convulso elemento vitale, nel suo saper fare e risolvere tutto in modo tecnico, è completamente proibita e negata. Perché, come insegnava Philippe Roth, vivere non è capire bene le persone ma capirle male, e poi male, e poi ancora male.
Se la vita gioisce nella vita, scriveva William Blake, i fatti non sono la verità e il vivere gioisce anche negli errori ed esagerazioni, ci insegna e dice, magnificamente, Francesca Archibugi.
[Fabio Sommella, 29 settembre 2019, fabiosommella@hotmail.com]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)