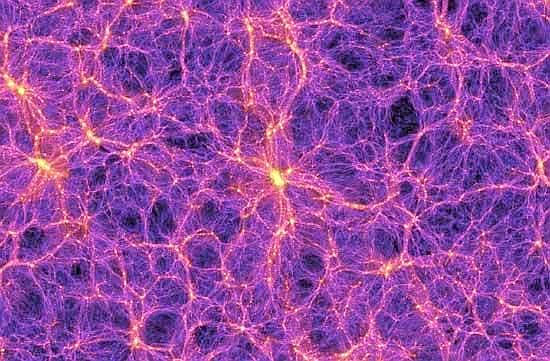Già dalla prima poesia – un sonetto, come la maggior parte dei componimenti vernacolari della sua raccolta Poesie Romane [ottobre 2020, PressUp, Formello (RM)], – Paolo Emilio Urbanetti getta i paradigmi del suo poetare: “SÒ MASCHERE”, infatti, la dice lunga su quanto saranno i successivi versi, probabilmente un nascondiglio, un abito – analogo a quello con cui i poeti satirici della Storia o del Teatro (si pensi ad alcune maschere di Ettore Petrolini o di Gigi Proietti) hanno bersagliato i poteri costituiti – con cui celare sé stesso in modo congeniale per osservare il mondo e parlarne con maggior schiettezza. Ciò non appare estraneo a un autore come Urbanetti che – per chi ha avuto modo di conoscerlo, seppure relativamente da poco, e certo apprezzarlo – trasmette una forte identità culturale, quella che una volta – con termine probabilmente desueto e alquanto riduttivo – si sarebbe detta umanistica. Ciò è ancor più vero non solo per i suoi studi filosofici, non solo – per sua stessa ammissione – per le letture ammirate e certo meticolose del suo modello poetico Giuseppe Gioacchino Belli, ma ancor più perché nel corso della sua vita l’autore, figlio di un medico, è passato attraverso molteplici esperienze, anche professionali, non ultime le varie frequentazioni con grandi personaggi dello spettacolo e luoghi d’arte (a riguardo si leggano le poesie ER CICERONE…). Tutto ciò ha arricchito e acuito l’innata sensibilità dell’autore, le sue doti di scrutatore della realtà, le sue indubbie capacità di indagatore della natura umana, la sua filosofia sorniona, forse scettica, in parte epicurea. Partendo da queste premesse, pertanto, cerchiamo di dipanare e approfondire la fitta rete di temi di cui è intessuto il libro Poesie Romane, testo che si fregia di un titolo volutamente generico e minimalista, come se l’autore volesse mimetizzarsi davvero e osservare senza esser osservato.
In LA MACHINA DER TEMPO l’autore, come certo a molti di noi sarà capitato, si cosparge il capo di cenere tra rammarichi non detti ma intuiti; poi ne LI BONI PROPOSITI procede con il rimpianto di una vita approcciata con semplicità. Ma dopo qualche altro passaggio – folclorico e talvolta oleografico – il tono s’innalza improvviso e diviene solenne, volgendo ad altezze somme; è quando, ne ER MISCREDENTE ALL’ARACELI, con il verso “Roma da lassù pare lontana” si colora – si lasci passare l’ossimoro – della sacralità dell’ateo e, nella vastità di un corale che trapela dal foglio stampato e viene avvertito dal lettore ormai sgomento, “sale piano piano er canto” di uno dei più antonomastici brani liturgici natalizi (“canto pur’io Tu scenni da le stelle”). È – questo richiamo a una sacralità non ovvia, non tradizionale, sopita ma che non sorprende e che ritroveremo più avanti – l’accento alto che svetta decisamente tra le prime composizioni. Così il tono natalizio ha il suo dignitoso e accorato continuum ne ER PRANZO DE NATALE che brilla di perenni luci con quegli altri accenti conferiti da un “libro” reperito “giù a Panico”, dal cogliere “’n sapore antico”, dal gustare “sti sorisi, st’occhi belli”.
Ecco quindi che, nel lettore, si fa strada la percezione che anche nel poetare di Urbanetti sia rintracciabile quella sorta di non nuova, ma di certo presente nella buona letteratura, Isola non trovata di gucciniana memoria (anche se Guccini, a sua volta e per esplicita onesta ammissione, l’ha ovviamente pescata da altri modelli letterari): si tratta del non manifesto, dell’agognato pur se non necessariamente esistente, dell’intravisto, dell’anelato, pur nel dubbio e nello scetticismo. Ciò è tangibile ne L’ATTIMO dove echi oraziani, ma anche dell’Autogrill del Maestrone pavanese, sono meravigliosamente resi (“T’ho vista su quer ponte, camminavi / cor vento che t’arzava la gonnella, / parevi penzierosa ma eri bella / che poi, vallo a sapé quer che penzavi” e nella coda “nun t’ho più vista e l’attimo è passato / quel’attimo… volato via così: / quer che poteva esse e nun è stato.”). Questo moto d’inarrivabile raggiungimento, pur nella consapevolezza del desiderio ineffabile, compare chiaro e netto (quasi fosse un manifesto programmatico nei confronti delle pretese neoromantiche o neo-stilnoviste dell’amata) anche ne LA MUSA CAPRICCIOSA. Altre volte, invece, è la consapevolezza della casualità, come ne ER SEME DELL’OMO (“Er fatto è che noi semo quer che semo / pe’ tanti cazzi e pure un po’ pe’ caso”). Pertanto si profila, come uno dei cardini della poesia di Urbanetti, la duplicità o il dualismo tra la consapevolezza del mero possibile e il viceversa desiderato.
Ciò si tocca, vividamente, anche in altri sonetti come ne ER CELO DE ROMA (“Puliscilo sto celo tramontana / e facce respirà sopra sta tera”, versi contrapposti ai seguenti “O forze saria mejo ‘na buriana / che ce spazzasse via, razzaccia nera”), ma senza dubbio ancor più in URBI ET ORBI (“In quer momento tutto s’è fermato / mijardi de perzone in lontananza / guardaveno a quel’omo sur zagrato.”). Poi, ne ER VECCHIO PAPA, la coesistenza di motivi duplici – se non la già citata sacralità dell’ateo – diviene pura coscienza vibrante di emozione (“Nun ciò gran confidenza co’ la fede / e a dilla tutta quanta, onestamente, / io credo solo a quello che se vede / però quer vecchio papa inginocchiato / pregà pure pe’ ‘n poro miscredente… / io, che ve devo dì, l’avrei baciato.”).
Un elemento ulteriore, secondario ma non certo trascurabile e che non poteva mancare data la scelta del genere letterario nonché il modello di riferimento belliano, è la satira sociale, fino alla dissacrazione potente come ne LA MEMORIA CORTA, sana e lecita denuncia socio-politica delle vicende storiche degli ultimi decenni, oppure in ARANCIA, BIRA, COCA. E, se non è satira, è certo comunque critica dai mille volti, come ne LA LEGGE NOVA o ne ER BER PAESE.
Altre volte, dopo ulteriori parentesi di costume tipicamente romanesco, si stempera la malinconia degli anni, che trascorrono e avanzano, mediante lo splendido invito degli affetti ne LI SESSANTACINQUE (“Sessantacinque embè? Fòri c’è ‘r zole”) o, anche, in NOI DUA o nella tenerezza di NATA AR POLICLINICO. È una malinconia, questa di Urbanetti, che può assumere varie forme: i toni delle amicizie perdute ne ER QUATTRO DE NOVEMBRE, il dualismo di CICCIA E FUFFA; de LA VENA SECCA (“Er monno de ’n poveta se ne fotte / la gente ride, scopa e vo magnà.”); di ER TALENTO SPRECATO fino al senso di dolore di L’AGNELLO SCANNATO (“‘N agnello fora de l’ammazzatora (…) così me sento, giuro, quarche vorta”). Viceversa, la vena malinconica, può capovolgersi e diventare l’ironia affettuosa di ER PIPPONE, l’accorata fraternità goliardica de LI TECNICI, fino alla gaia autobiografia de ER FRUTTO (“Partirono un ber dì tra er lusco e ‘r brusco / e ‘r frutto che sortì da quel’amore / sò io, mezzo romano e mezzo etrusco.”).
All’interno della propria romanità – avvolgente e che abbraccia nostalgie financo di avanspettacolo, come in ALL’AMBRA JOVINELLI! – Urbanetti compie però un utile e illuminante distinguo. Questo avviene in SÒ GUSTI, dove l’autore travalica i citati pur non dominanti aspetti folclorici e di costume in favore di scelte, di posizioni, di fisionomie artistiche ed estetiche. Pur diversamente accade anche in TORE MAURA, ne LA VITA DER TOSSICO, ne LI BONI CRISTIANI dove si dà voce, eterogenea e gravemente amara se non efferata, alla disperazione delle tante altre Rome, transitando per la giocosità de LI COATTI SCONVORTONI (con indubbi echi della Storia disonesta del compianto Stefano Rosso), per il duro dualismo de LA GRANNE BELLEZZA (“Romaccia mia vergine e puttana”), fino ad affrescare – alla barba di qualsiasi reazionaria Vecchia Roma – il Villaggio Globale, culla del Melting Pot, nell’intensa PIAZZA VITTORIO.
Volendo cercare, in definitiva, un denominatore comune fra i tanti temi delle Poesie Romane – in prevalenza sonetti – di Paolo Emilio Urbanetti, si può e si deve affermare che l’ironia, talvolta il sarcasmo, fanno da contraltare a un malcelato anelito inappagato che transita attraverso la romanità – pretesto contingente (abito di scena, appunto) – magnificamente trascendendola, osservandola allargarsi al mondo e alle sue antinomie, limiti e rabbie, nascondendosi l’autore solo in apparenza dietro una maschera benevola e sorniona, oltre la quale egli piange e si diverte, si rammarica e sorride, ridendo di sé stesso e carezzando la vita come ne ER MORTORIO MIO (quanto, anche qui, del Guccini de L’albero e io?), sonetto che conclude l’antologia con scultorei versi epigrafici: “Me piacerebbe fallo a fine estate / cor ponentino fresco de staggione, / ‘na pietra abbasterà ‘ndo ce lassate: QVI GIACE ER PECCATORE IMPENITENTE / FILOSOFO POVETA E CICERONE / CHE MAI CAPÌ CHI FVSSE VERAMENTE”; ovvero: la leggerezza del “ponentino fresco” e la “pietra”, insieme, per un ennesimo pregnante dualismo.
[Fabio Sommella, ottobre 2020]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)