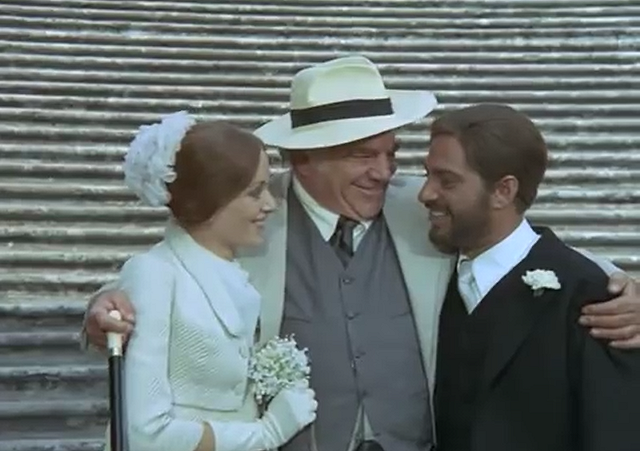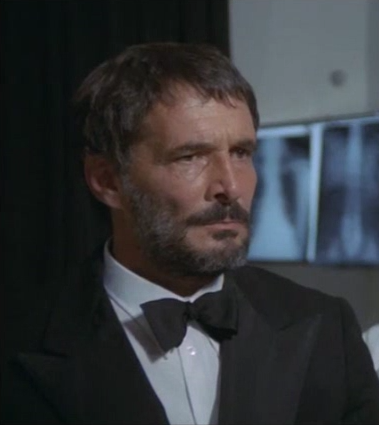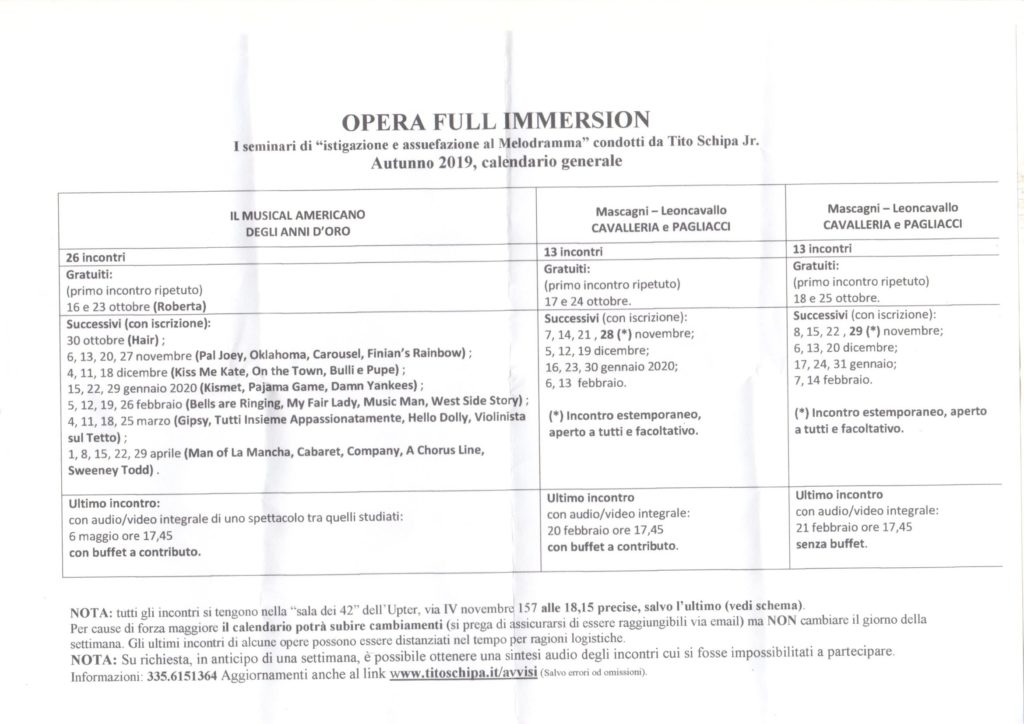Analisi semantica di quattro film è un mio libello (pamphlet) comprendente quattro articolate riflessioni – originatesi in un arco di tempo di oltre vent’anni (dagli ’80 ai primi 2000) – attorno a quattro grandi film d’autore.
La prima edizione, cartacea, edita da Boopen, risale al 2008; la ristampa, ebook (PDF), con LULU è del 2015.
Successivamente, alcuni corposi contenuti – quelli pertinenti a C’eravamo tanto amati e a La meglio gioventù – sono confluiti, pur riveduti e ampliati, nel mio Il cambio della guardia pubblicato dapprima da Caosfera nel 2016 (edizione oggi fuori catalogo) e poi pubblicato e inserito nella mia vetrina Amazon nel 2019.
Qui di seguito propongo la Prefazione ad Analisi semantica di quattro film, ristampa 2015 [il libro in formato ebook PDF è acquistabile al link Analisi semantica di quattro film – Ristampa 2015 (lulu.com)] Oggi probabilmente rivedrei la forma, per renderla più snella, ma il contenuto credo sia sempre valido. Pertanto auguro, a chi vorrà, di nuovo
buona lettura.
Fabio Sommella, 23 agosto 2021
========================================
- 1 Prefazione
Parafrasando(1) H. Tajfel e C. Fraser, che a riguardo della loro
disciplina sottolineavano la competenza in certa misura
acquisita da parte dell’uomo comune (anche Sigmund Freud(2),
nel loro carteggio epistolare, appellava “fortunato” il professor
Albert Einstein in quanto nessun uomo, che non conosceva la
fisica, si sarebbe mai permesso di giudicare la sua opera;
viceversa tutti si permettevano di criticare la Psicoanalisi),
possiamo affermare che siamo tutti cinèfili o, pur
impropriamente ma in modo più circostanziato, amanti dei film
(certamente il primo termine appare senz’altro più nobile).
Ovvero: tutti, o quasi, siamo perennemente, o frequentemente,
attratti dalla magia del cinema.
Tuttavia, più probabilmente e in generale, oltre che dalla
congerie di elementi tecnico-spettacolari di “quell’enorme
baraccone chiamato cinema”, ciò che più ci attrae nei film sono
i racconti, le storie, i personaggi, i simboli, manifesti o celati, e
quindi, in una parola, i significati che questi, nonché le loro
vicende, incarnano e rappresentano. Così come giungono a noi
i lontani miti e le favole/fiabe che le nostre mamme e nonne, e
poi le tradizioni popolari e letterarie dei diversi popoli, ci
hanno trasmesso e si tramandano da quando esiste l’uomo (e,
forse, ancor prima), così nel nostro cuore, perenni bambini mai
cresciuti, seppure adulti abbiamo necessità e ci nutriamo dei
moderni percorsi dei protagonisti di storie di qualsiasi natura:
narrativa, poetica, figurativa, musicale, teatrale,
cinematografica, fumettistica, iconografica, multimediale …
(aggiungerei anche matematica, ma …); e così sarà, per noi,
per la nostra coscienza e la nostra psiche più profonda, finché
non calerà il sipario (e, ancora forse, anche oltre).
Ne consegue che, in base ai convincimenti di cui sopra, un
lettore/fruitore di queste storie non può non porsi anche di
fronte ai film, perlomeno ad un certo tipo di film, in modo non
dissimile a quello con cui si pone di fronte alla letteratura o ad
altri dei suddetti generi, espressioni tutte dell’arte di
“raccontare”, pur con differenti linguaggi e metodi.
Da queste premesse sono nate, negli ultimi quindici anni, le qui
presenti mie quattro analisi semantiche dei seguenti film: - Otto e ½ – di Federico Fellini (1963)
- C’eravamo tanto amati – di Ettore Scola (1974)
- Luna di Fiele – di Roman Polanski (1992)
- La meglio gioventù – di Marco Tullio Giordana (2003)
Non me ne vogliano gli autori, con i quali innanzitutto (pur
indirettamente) mi scuso, se un non addetto ai lavori si è
permesso di esaminare, con l’approccio ed un fare ed un dire
del critico del settore, alcune delle loro più pregiate opere
(senz’altro questo è stato fatto con estremo amore e
ammirazione e per puro spirito costruttivo e conoscitivo).
Troppo ghiotte, dall’inizio della mia età matura, mi sono
sembrate le varie occasioni di cimentar me stesso, “olistico
ricercatore” in vari ambiti e settori, con i significati che a me,
spettatore/lettore di queste opere/racconti, apparivano così
prepotentemente fuoriuscire da loro stesse. La loro forza
poetica, esistenziale, psichica, politica, culturale, storica,
simbolica, onirica, planetaria, sovratemporale … trapelava ad
ogni, spesso, ripetuta visione; vi emanava come maggiori
entità, presenze naturali o sovrannaturali che, attraverso questi
film, mi parlavano di una saggezza, pur nascosta e segreta,
profonda ed eterna che, appunto, travalica lo spazio ed il
tempo, hic et nunc, durante la visione e ancor lungamente
permanente successivamente ad essa. Come raccontava il
grande Massimo Troisi: da giovane egli era rimasto affascinato
dalla visione del film “Medea” di Pier Paolo Pasolini, pur,
precisava sempre Troisi, non avendone capito quasi nulla; così,
o analoga mi sento di affermare, era stato il mio sentire
all’uscita del cinema Metropolitan di Roma dopo la visione di
“C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola. Una sorta di
folgorazione, una fascinazione profonda attorno alla storia, alla
narrazione, ai personaggi, alle loro vicissitudini e alle loro, pur
tristi e amare, evoluzioni (tant’è che, ogni volta con maggior
piacere “filmico”, negli anni seguenti rividi lo stesso film
almeno altre dieci volte in altrettanti cinema).
Sono queste cose, queste presenze, questi umori-fermenti ed
elementi poetico/razionali, definiti-indefiniti, che, mi auguro
con un buon livello di analisi semantica ed espressione critica,
ho cercato, naturalmente e istintivamente ma accompagnati
dall’analisi delle strutture e delle relazioni narrate, di
imprimere ed esprimere in questi quattro, più o meno brevi (le
sezioni relative a “C’eravamo tanto amati” e “La meglio
gioventù” sono senz’altro quelle di più ampio respiro), saggi
critici. E, malgrado l’indubbio interesse che mi suscitò
all’epoca, almeno coscientemente poco è valso, o poco è stato
utile nel preparare il presente lavoro, il corso di
alfabetizzazione/critica da me frequentato nell’anno 1996
presso la sede AIACE di Roma: senz’altro utilissimo a
comprendere le basi fondamentali del linguaggio
cinematografico (inquadratura, sequenza, il montaggio come
grammatica delle frasi del cinema, …); ma qui, senza nulla
togliere a quanto appena citato ma senza neanche voler
sminuire la portata del mio lavoro, si parla quasi di altro. Per
comprendere pienamente ciò che si intende, vale quanto cito in
una nota successiva: “(…) saggio critico su un film visto da un
non addetto ai lavori; un oggetto d’arte, un mezzo espressivo
(al di fuori della tecnica cinematografica ma dentro la
letteratura)”.
Naturalmente, non si pretende certo di aver esaurito i significati
intrinseci a queste opere; sarebbe, si perdoni il paragone, come
se si intendesse esaurire la simbologia dantesca o omerica con
una lettura critica di qualche decina di pagine. Nondimeno, si è
certi d’aver colto e trattato almeno alcuni dei principali
elementi semantici e poetici di queste opere. Laddove si era
consapevoli di non aver effettuato tutto il percorso critico, si
sono lasciati volontariamente aperti, anche solo accennati,
alcuni sentieri ulteriori. E chissà se in seguito, magari a fianco
di un’analisi semantica di “Fanny e Alexander” (storico
capolavoro di Ingmar Bergman, summa di tutte le principali
tematiche, e significati, dell’opera cinematografica del maestro
svedese) questi non vengano ripresi e approfonditi
ulteriormente.
Tutto ciò premesso, mi auguro che il lettore faccia uso di tale
approccio metodologico: ciò che parla, in questo lavoro, è lo
spirito dello spettatore che viene colpito, in positivo, dalla
forza delle vicende che si svolgono all’interno di questi quattro
film. Come è già capitato di sostenere e scrivere (ma non sono
certo il primo né sarò l’ultimo ad affermare ciò), ogni
spettatore/lettore/fruitore, completa, con la propria esperienza,
l’opera d’arte e ne osserva e trae significati spesso anche ignoti
agli autori stessi: del resto, a mio avviso, non è ininfluente
affermare che uno dei mestieri più affascinanti sia quello del
critico letterario (a dispetto di quanto a volte sostenuto anche
da qualche grande protagonista del teatro del secondo
novecento; ma, in tal caso, subentravano probabilmente “fattori
di disturbo esterni” quali, non ultimi, i rapporti conflittuali nei
confronti della critica cosiddetta “togata”), almeno di colui che
svolge tale attività, creatività critica, affiancandola alla
creatività creatrice delle opere (un modello, in tal senso, è stato
senz’altro Ugo Foscolo, sia autore di letteratura che critico
letterario).
Alla luce di questi elementi, e premettendo che per
comprendere, concordare o dissentire con quanto ho scritto, è
necessario aver visionato e, almeno un pò, amato i film qui
presi in esame, auguro di cuore buona lettura e buona “discesa”
nei significati di questi quattro, a mio avviso grandi, racconti
filmici.
Fabio Sommella
Roma, 13 gennaio 2008
(1) Henri Tajfel, Colin Fraser: Introduzione alla psicologia sociale; Il Mulino, Bologna, 1984,
pagina 15: “Siamo tutti psicologi sociali. (…)”.
(2) Albert Einstein: Il lato umano; Einaudi, 1980, Seconda edizione, pagine 33-34.
===============================================

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)