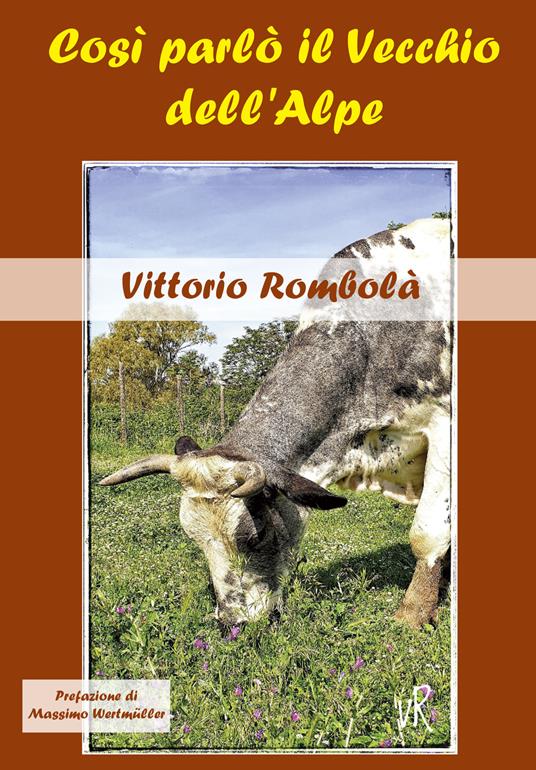Nella serata del 21 maggio 2024, in una fascia oraria ottimale (18-19:30), in una sontuosa sala del Palazzo Mattei-Paganica, sede dell’Istituto Treccani di Roma, sita in piazza dell’Enciclopedia Italiana 4, Pandora Rivista ha organizzato l’interessante dibattito intitolato Viaggio nella cultura: reti, forme e mappe di un mondo in trasformazione. Il dialogo, moderato dal direttore della medesima rivista Giacomo Bottos, ha visto come principali interlocutori Paolo Di Paolo, Loredana Lipperini e Giorgio Zanchini. In sala, tra il folto pubblico partecipante, c’era l’editore Giuseppe Laterza che pure è intervenuto con stimolanti riflessioni.

Va detto subito che l’evento, caratterizzato dal pregnante sottotitolo reti, forme e mappe di un mondo in trasformazione, non ha deluso affatto bensì è risultato estremamente interessante. Qui di seguito cercheremo di evidenziare i molteplici motivi di questo interesse.
I tre abili oratori intervenuti, nel pur relativamente breve tempo a disposizione, hanno cercato di sondare e indagare quelle che, nel controverso panorama della contemporaneità, personalmente definisco le silenti ed eludibili Forme della Cultura.
In tal senso mi è parso illuminante l’esordio dialogico di Paolo Di Paolo che, dopo aver ricordato che quest’anno cadono i cento anni dalla pubblicazione de La montagna incantata di Thomas Mann (ambientato poco prima della Grande Guerra, questo romanzo tratta di un’epoca incerta e frammentata, per molti versi analoga alla nostra attuale), ha parlato di Volubilità della cultura contemporanea, ricordando da una parte il concetto di Effimero, quello delle Estati Romane di Renato Nicolini, contrapponendolo in qualche modo e misura a quello di Tangibile, o preteso tale, probabilmente della cultura de jure di vecchia nozione tradizionale o scolastica. Se da una parte, da anni o decenni, si assiste a un progressivo processo di frammentazione culturale (personalmente parlo anche di rarefazione), utile è stato pure il richiamo a Tullio De Mauro, alla sua Passione civile (2004) e al suo concetto di Lifelong Learning o Istruzione Permanente per gli Adulti. In questo scenario, probabilmente vige una relazione (anch’essa permanente?) tra la suddetta volubilità e l’effimero nicoliniano, nonché sussiste una plausibile relazione ciclica con l’ormai purtroppo abusato (ma Di Paolo rimarcava l’originalità e la forza di tale intuizione negli anni ’90) di Liquido e di Società Liquida di Zygmunt Bauman.
Loredana Lipperini, riferendosi ai Festival e alle Comunità culturali letterarie, ricorda da principio Leonardo Sciascia quando, negli anni ’80, lo scrittore siciliano ammoniva circa l’allontanarsi della meta, ella aggiungendo poi che, oggi, la medesima non si vede più. In tal senso è utile recuperare il concetto di Luciano Bianciardi di Lavoro Culturale (in passato ne ho anch’io argomentato nel mio Passaggi molteplici nel romanzo postmoderno: Bianciardi, Calvino, DeLillo, Eco, ma si veda anche qui).
A riguardo, va ricordato che, nei primi ’50, Bianciardi vagava per il grossetano con un furgone da cui si diffondevano le note di Luci della ribalta” di Charlie Chaplin, con lo scopo di “acculturare” gli abitanti di quel territorio che lui, forse con una buona dose di autoironia, considerava la sua Kansas City (a sua volta imparentata con la Rimini felliniana de I Vitelloni.) Poi, probabilmente, la tragedia di Ribolla lo indusse a cambiare qualcosa e concepì il progetto dinamitardo, abortito, che gli ha permesso di scrivere La vita agra della Milano del boom/sboom. Ma la rilevanza del Lavoro Culturale resta e fa piacere, pur settanta anni dopo, recuperarlo dalla polvere del tempo per renderlo di nuovo vivo nell’era digitale e della vaporizzazione.
In tal senso Lipperini ha sottolineato come il prodotto culturale non sia da intendere solo come libro ma esso comprenda un’ampia varietà di elementi diversi tra cui i manga, i fumetti, i video giochi, le serie TV, i Social, nonché i libri di genere minore. Inoltre Lipperini ha sottolineato come vigano forme subdole, forse latenti, di capitalismo culturale laddove si invita sempre e solo a ragionare sui numeri. Da contrapporre a ciò è l’Utopia, ricordata da Lipperini in due nomi: quello di Steve Jobs, quando questi nel 2005, pur con qualche rischio, invitava i giovani a “essere pazzi”; e poi quello di David Foster Wallace con il suo discorso sulle libertà e quindi di nuovo sull’Utopia.
Giorgio Zanchini, come giornalista culturale, ha indicato l’accentuazione (potremmo anche dire esasperazione) del processo trasformativo culturale ricordando che, una volta, autorità e gerarchie erano riconoscibili mentre, oggi, la digitalizzazione ha evaporato tutto. Ma la Sfera Pubblica oggi è comunque densa. A tal fine Zanchini ha citato Mario Tedeschini Lalli, con il suo Medium secondo cui è vasto, e non ben conosciuto, l’attuale campo dell’offerta culturale. In tal senso si dovrebbe abbandonare l’idea che, se i giornali “non vendono”, sia una questione di contenuti: se i giornali non vendono è una questione di forma. Necessita una Piattaforme di Relazioni Sociali in quanto, oggi, chi fa giornalismo è solo un piccolo pezzetto di quella che è la Catena di Valore. Oggi c’è difficoltà di trovare territori comuni condivisibili.
L’editore Giuseppe Laterza ha poi fornito una magnifica definizione, antropologica, di cultura (io rammento quella, pure antropologica, secondo cui la cultura è una caratteristica della specie umana, analogamente alla proboscide o alle zanne per la specie elefante) secondo la quale essa è una serie di determinazioni/concettualizzazioni storicamente determinate che risponde a un bisogno. In tal senso l’editore ha poi stigmatizzato come il libro del generale Vannacci abbia venduto 500.000 copie, secondo solo a quello del principe Harry (sigh!) Pertanto vigono comunità e gerarchie “culturali” e, nella Scuola, si dovrebbe imparare a distinguere tra un film di Francois Truffaut e uno di Bombolo, che pure ha una sua dignità culturale. Inoltre ci sono i fattori storici: in tal senso Giuseppe Laterza ha raccontato il gustoso aneddoto secondo cui Benedetto Croce considerasse “cialtrone” Sigmund Freud che aveva scritto un libro intitolato Totem e Tabù.
Loredana Lipperini, ricordando poi Michela Murgia, liquidata spesso come una banale influencer, ha ribadito che il Lavoro Culturale si fa anche sui Social e che non è un qualcosa da svolgere nei ritagli di tempo bensì a tempo pieno.
Paolo Di Paolo ha quindi invitato gli astanti a procedere con il pensiero, non pensando al ‘900 come all’unico mondo possibile. I suoi maestri universitari, De Mauro e Asor Rosa, non liquidavano uno spazio dell’Estetica come Etica. Il libro va concepito non come un punto di partenza ma come un punto d’arrivo. In tal senso ha citato Giovanni Solimine: Cervelli Anfibi. Oggi sullo smartphone, giornalmente, transitano in media 100.000 parole. La lettura è frammentata – potremmo dire de-regolarizzata – ma non è vero che i giovani leggono di meno.
Giorgio Zanchini, infine, ha richiamato l’attenzione sui mediatori vecchi e nuovi, sui buoni filtri come Loredana Lipperini e sui cattivi filtri, come certi influencer, citando il suo amico Matteo Cavezzali e Ravenna.

Grazie quindi a Pandora Rivista e all’Istituto Treccani, abbiamo avuto l’opportunità di assistere a un’appassionante maratona attorno alle trasformazioni formali della cultura nel nostro tempo, un incontro che rende giustizia ai tanti modi diversi, oggi, di fruire e veicolare gli elementi culturali rispetto a quelli rigidi del passato e che taluni, probabilmente, vorrebbero cristallizzati secondo criteri e modelli sovratemporali: ma, per fortuna, non è così!
In definitiva, al di là della sopravvivenza (qualcuno potrebbe chiedersi “Il problema è adeguarsi ai tempi o rimanere ancorati ai valori con cui siamo cresciuti ?” Personalmente penserei né l’uno né l’altro), credo il nodo sia sapersi confrontare a tutti i livelli – ossia come fruitore, autore, editore, distributore… cittadino – con la rarefazione e la vaporizzazione (come ha rimarcato Di Paolo, sorpassata è, ormai, anche la “liquidità” della società di Zygmunt Bauman dei ’90) del fatto culturale. Come indicato da Laterza, ci si scontra proprio con il parlare alla Vannacci o sullo scrivere del principe Harry e non si fa uso di una forma d’intelligenza utopica che è l’unica che può salvarci dignitosamente, al di là della mera sopravvivenza. Come suggerito da Lipperini, la sfida (del Nuovo Millennio?) per gli Intellettuali è il Lavoro Culturale H24 attraverso tutti i molteplici canali in grado di veicolare questo processo.

[Fabio Sommella, 22 maggio 2024]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)