E
come i violinisti del Titanic
suonar
nel tuo pensiero i
Mille giorni di te e di me
mentre tutto intorno
procede alla deriva.
[Fabio, 5 aprile 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
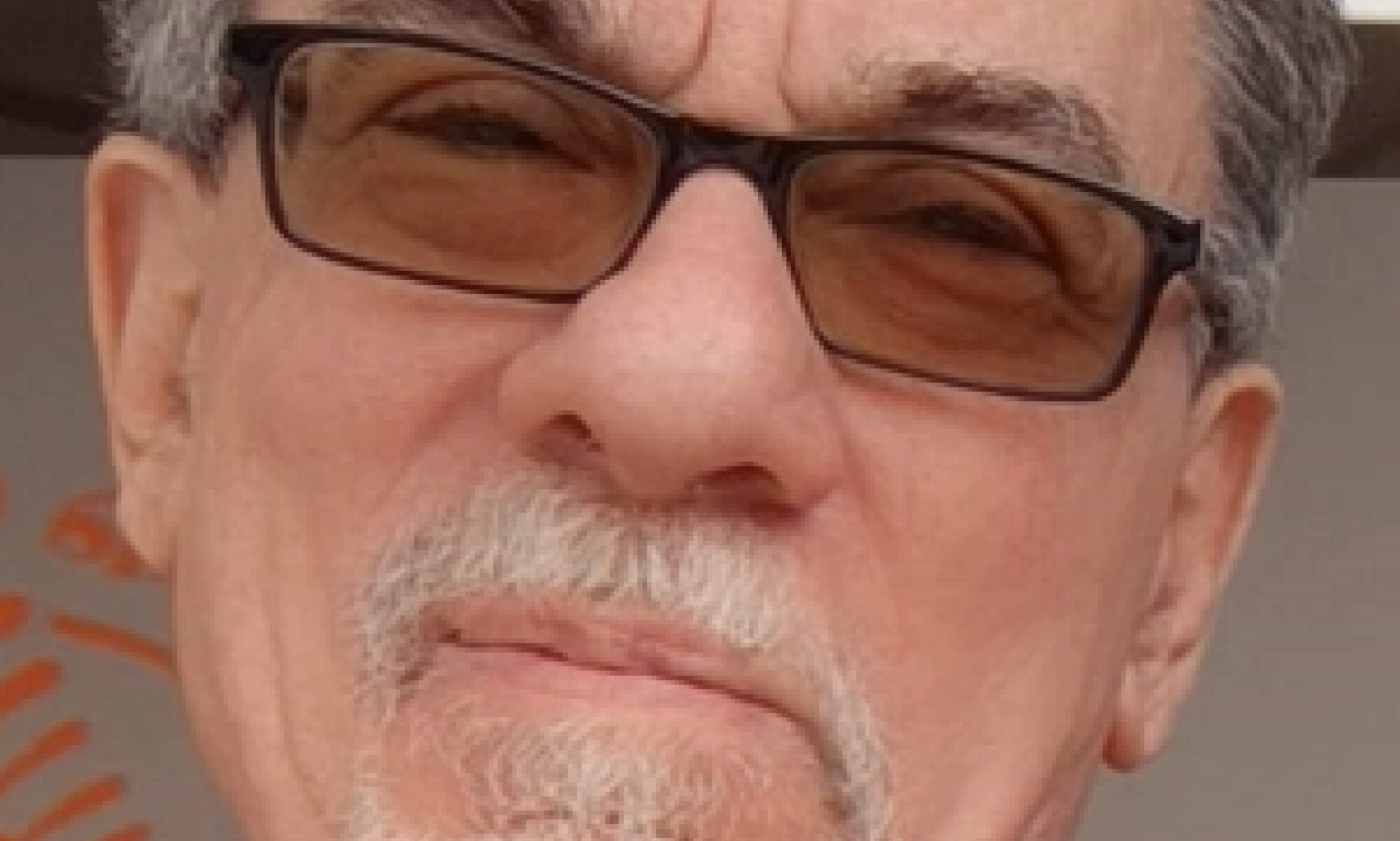
Trasversalità, contaminazioni culturali… di Fabio Sommella
E
come i violinisti del Titanic
suonar
nel tuo pensiero i
Mille giorni di te e di me
mentre tutto intorno
procede alla deriva.
[Fabio, 5 aprile 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
Un gustoso, garbato, umoristico e assennato ritratto di una trasformazione: quella pertinente all’«uomo che non deve chiedere mai». Tutto scritto in una intrigante prima persona, se le vicende iniziali del protagonista nascono, salgono crescendo fino a risultare – volutamente – ossessive e financo stucchevoli, quelle successive interrompono al momento giusto le prime per dare spazio a un riemergente senso di umanità e tenerezza, a un’arguzia e a un’autoironica introspezione che allargano l’orizzonte e la scena liberandoli da quella claustrofobia che stringevano nell’asfissia il lettore nei primi capitoli. L’eco del racconto filmico Quando eravamo repressi, 1992, di Pino Quartullo sovviene inevitabile al lettore che ha amato quel tipo di agrodolce ironia sulle ferite auto-inferte ai sentimenti. Complimenti a Sam Stoner – che certamente non ha bisogno di quelli di chi scrive queste righe – per una splendida prova d’autore, sempre in bilico fra buongusto e ricerca dell’effetto dissacrante di un certo tipo di costume, diversa da quella pure magistrale di “Elvis Rosso Sangue”, nella quale però gli eccessi splatter e le tinte forti erano – anche qui, volutamente – estremi fino al parossismo. Pur sfondando una porta aperta, piace ribadire che Sam Stoner è indubbiamente equipaggiato delle necessarie doti narrative e stilistiche tanto per i noir e thriller che per gli arguti e brillanti ritratti psico-culturali di genere. Da leggere, irritandosi nelle prime pagine, intenerendosi nelle ultime. 😊
Vetrina: https://www.amazon.it/Lamore-questo-bastardo-Sam-Stoner-ebook/dp/B00RGYDX8Y
Posted anche su FB al link https://www.facebook.com/PierreBezuchov0 in data 04APR2019

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
Toccanti testimonianze (fare clic sulla foto). Ringraziando gli amici Dario Amadei ed Elena Sbaraglia, del Magic BlueRay, ho preso in prestito la loro bella foto perché esemplificativa di cosa e come.
Come sospeso tra una dimensione espressamente scientifica e una, viceversa, manifestamente umoristica – riecheggiante, sul primo versante, il Musicofilia di Oliver Sacks mentre, sul secondo, (qualcuno lo ricorderà?) il Carugati di Gino Bramieri (!?!) – Amore e altre psicopatologie (Desmond Avenarius, editore Graphofeel, 2018) si presenta come una simpatica prova d’autore di genere narrativo-saggistico-comico-grottesco. L’epigrafe di premessa, ripresa da Arthur Schopenhauer e riferita all’amore inappagato per Laura da parte di Francesco Petrarca, già annuncia l’impianto eminentemente biologistico-naturalistico che sorregge l’intera opera, a discapito di qualsiasi possibile sovrastruttura astratta e metafisica.
La prima e più voluminosa parte si articola in una serrata sequela di fantasiosi e gustosi casi clinici. Tema: la psicopatologia dell’amore. Ma in tutto il libro, all’interno di una folta galleria di annotazioni aneddotiche, se ne riconoscono e memorizzano alcune davvero esilaranti: il Giannino alias Lupo e la Pina alias Cappuccetto Rosso; l’acquisita maturità sessuale d’un protagonista in concomitanza della storica Italia-Germania 4 a 3 del ‘70; il “Sesso con piacere” della tribù amazzonica degli Zanduka (?!?!), per molti versi riecheggiante da una parte il “Sesso senza amore” di un’altra tribù, quella televisiva di Dandini/Guzzanti di qualche anno fa, dall’altra il Bunga Bunga di un premier, pure di qualche anno fa.
È in questo modo che prendono corpo una serie di storie, vicende, immagini dense e ricche di colore, iperboliche, paradossali, anche surreali. La galleria umana, spesso goliardicamente estrema, non escludente pur lontani echi boccacciani-boccacceschi del filone commedia filmica italiana ’60-‘70, talvolta volutamente financo mandrillesca, non oltrepassa mai i limiti del buon gusto. Il lettore risponde al simpatico strizzar d’occhio degli autori e viene sapientemente condotto fra tragiche disavventure di traumi affettivo-amorosi e galanti avventure sentimentali. Tutti gli avvenimenti iniziali degenerano inevitabilmente in dolori dell’anima; ma, proprio grazie al professor Desmond Avenarius, tutto viene sempre risolto, puntualmente. Altrimenti non ci sarebbe necessità del suo intervento, analogamente a quanto avviene nella fiction Don Matteo, in cui è richiesta la redenzione, altrimenti non ci sarebbe necessità del sagace ed evergreen sacerdote. Pertanto, anche qui, avviene sempre la guarigione dei pazienti, tanto di quelli cronicizzati, quanto di quelli vittime delle fasi acute della psicopatologia denominata Amore.
Le mirabolanti vicissitudini, ovviamente, vogliono essere e sono l’autentico punto di attrazione del libro in cui. all’interno di una dimensione narrativa affabulatorio-fantapsicologica, si concede largo spazio all’ironia e alla satira dei costumi umani. Ma l’epicentro e fil rouge, il punto di inevitabile arrivo, è il meta-magico-scientistico elettroerototropion. Quest’ultimo strumento centrale, sorta di black box (della sua costituzione ne viene fornita una sommaria descrizione in Appendice), dati degli elementi in ingresso (la psiche del paziente), è in grado di discernere e chiarire le cause dei dolori dell’anima, generando di volta in volta in uscita delle risposte diagnostico-terapeutiche. Queste sono inequivocabili, fondantisi sulla scienza dell’erototropiologia umana applicata, disciplina appunto fondata dal professor Desmond Avenarius di Trockenerhugell. Il lettore medio, erroneamente, potrebbe ritenere questa disciplina in qualche misura imparentata con la tropologia, ma certo in merito il prof. Desmond Avenarius sarà in disaccordo.
Nell’Appendice, infine, sono ricostituite, con indubbia verosimiglianza parascientifica, le basi teoriche che fanno da supporto alle dottrine del professor Avenarius: attraversando canoni e criteri di psicologia dell’inconscio, modelli antropologici ed etologici, criteri estetici di narratologia con finalità “biblioterapeutiche”, il lettore viene guidato a esplorare i capisaldi della erototropiologia. In particolare, toccando l’area della biblioterapia, viene adombrata l’ampia questione pertinente tanto alle modalità di fruizione delle storie raccontate quanto, ancor più importante, allo scrivere storie. È qui che, con un furore alla Savonarola, il professor Desmond Avenarius – o chi per lui – si scaglia e prende posizione in merito al proibire alcune storie, almeno in certe modalità (“libri che secondo me dovrebbero essere condannati alle fiamme senza pensarci un attimo”).
In ogni caso la fascinazione è assicurata, perché i capisaldi dell’erototropiologia umana applicata, partoriti dalla feconda mente dell’illustre neuroscienziato, al di là della dimensione finzionale saggistico-narrativa, divengono mete ideali e approcci di vita, richiamando – ancora una volta, perché no? – una rediviva Età dell’Oro (vagheggiata quasi sessanta anni fa anche da Luciano Bianciardi in chiusura della sua Vita agra), il desiderio di ritornare a uno stato di natura virginale che – superfluo dirlo – è perduto alle nostre latitudini e nella nostra civiltà. Luogo comune? Forse. Ma il lettore chiude il libro persuaso di trovarsi di fronte a un nuovo dominio di conoscenze sulla natura e psiche umana in cui la buona narrativa e narratologia assurgono a fondamenti. Chissà se l’erototropiologia sia il connubio di biblioterapia e musicoterapia medesime? In ogni caso non si può fare a meno di tessere simpaticamente le lodi del professor Desmond Avenarius e dei suoi fedeli collaboratori Dario Amadei ed Elena Sbaraglia.
[Fabio Sommella, 27 marzo 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
Mi sento solo, come ai miei dieci anni, o giù di lì. Allora erano le estati. Mio fratello era già fuori. Io ero in casa con mia madre. La finestra della stanza aperta (era estate!) Io, seduto sulla poltrona, quella di fianco al mobil letto. Mi rivedo: sto leggendo – ormai ho imparato, e non faccio più “tsktsk…”, come quando più piccolo guardavo le figure dei Topolini, fingendo di leggere quasi in codice Morse – sì; sto leggendo dei Tex, quelli a strisce da cinquanta lire, col cartoncino più spesso sul lato sinistro… come dire? “Rilegati”, e non con le crappette sempre sul lato sinistro, perché quelli erano i fascicoletti da trenta lire, di appena qualche anno prima.
Quindi sto leggendo Tex: è l’avventura importante contro Mefisto… sì, certo, contro Mefisto ce ne sono state già due, forse tre: ma questa è quando Mefisto si allea poi con il Baron Samedi e un gigantesco nero – di nome Dambo? – in Florida, a Tampa… insomma, stabilisce un’alleanza con un folle, scappato da un manicomio – ne abbiamo, adesso, anche qui, tra i personaggi pubblici? – e decide di sollevare la nazione Nera. Ci sono una miriade di neri, coperti da pelli di leopardo, che si muovono sinuosi e insidiosi lungo le acque della Savana dove, dice uno dei titoli, corre il Terrore. E loro due – Mefisto e Samedi – vivono in un castello di stampo medievale, nel cuore della Savana, da cui con un potente organo a canne, nei momenti di crisi mentale (!?!) di entrambi, o forse solo di uno di loro, s’irradiano tetre musiche in tutto lo sterminato aere circostante, in quel territorio, tra gli alberi, tra gli arbusti, fra i torrenti, i rivi, le vegetazioni, fino ai cieli della Florida.
Galep e Bonelli, sicuramente, diedero del loro meglio in quella sontuosa avventura che occupò, se non sbaglio, tra i quindici e i venti fascicoli da cinquanta lire.
Naturalmente Tex e Kit Carson – forse anche Kit Willer e Tiger Jack – sono chiamati ad affiancare le autorità militari del posto per sgominare la pericolosa congrega criminale di Mefisto, Samedi e compagnia.
Mi sento solo – adesso – come allora: allora ero su quella poltrona, a leggere queste storie, colorite, colorate seppure bianco e nero – era il ’68 – e trascorrevo le mattine attendendo chissà cosa: mio padre dal lavoro? Mio fratello dal mare? Il mio mare? Il trasferimento nella nuova casa, fuori, ai Castelli? – Romani, non Medievali! – Che tornasse ottobre? La crescita? Nuovi amici?
Intanto fuori era il Maggio, o era appena passato. File infinite di giovani variopinti popolavano le strade di Roma, in una promessa di protesta, d’amore, di gioia. Io avevo appena compiuto la Prima Comunione, insieme ai miei amici e amiche di Scuola da cinque sei anni – amici dai tempi dell’Asilo – che però non avrei più rivisto, perché, di lì a breve, avremmo cambiato casa, zona, quartiere. Quindi: nuovi amici, nuove scuole, nuove zone.
E cantavano le canzoni del tempo…
Mi sento solo – adesso – come allora. In ferie dall’annoso lavoro aziendale – cerco di riscattarmi facendo tante altre cose – mio figlio fuori all’UNI e poi, in serata, ai cinema-teatro di Roma – l’Adriano? Memorie di Beatles… – mia moglie, ormai, via da quel dì… i nuovi amori, lontani tutti… i cari amici, sentiti, spesso, ma non bastano, non riempiono, non saturano… guardo all’arco degli anni, dei decenni – tanti, troppi – trascorsi e… allibisco. Un cuore, una mente, da eterno ragazzo e un corpo e un’anagrafica – come ha detto stamane un carissimo amico per entrambi noi – da gerontocomio… inciampi in anomali scalini di bus-navetta, urti contro reti stradali invisibili ai tuoi occhi, ti scontri (!?!) contro pali stradali alla sera… passino pure i dislivelli o i marciapiedi non visti… ma che è?
E sembra allora che non sia passato poi tanto tempo… o che tutto il tempo passato, insieme ai suoi tanti eventi, ai trenta, quaranta, cinquanta anni – siano così… relativi, fatui, inutili – eh, certo, no, non del tutto, è? – sommari, tenui, scomparsi, imprevedibili, invisibili…
Così ti adagi in una nuova sorta di poltrona: attendi l’estate? Il mare? Tuo figlio? Un qualche recondito evento che ti faccia sentire… sentire vivo?
Nel frattempo ti raccomandi a Tex e ai suoi fedeli pards: non sparate, non sparate con l’artiglieria pesante: Mefisto e Samedi e Dambo sono anch’io, perché siamo tutti dei buoni amici, in definitiva… e, quello che corre sulla Savana, non è Terrore… è solo Vita!

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
[Massimo Moraldi, Fabio Sommella – 25 marzo 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
Sommario
Milan in my mind – V02
Prodromi 1
First time. 2
Poi 3
Occhi 3
Fra tumori e timori 4
Cosa resta?. 5
Ventisei anni. Dal ’90 al 2016. Ventisei anni di periodiche – a volte saltuarie, altre più frequenti – trasferte e permanenze a Milano. Tra viaggi di lavoro e nuovi Viaggi della Speranza. Questi ultimi almeno in due tornate. Se non erano di lavoro… due blocchi di viaggi – motivazioni diverse – alla ricerca di guarigioni. Nell’ex capitale morale.
D’altronde, se non per questioni di affari, se non era per cercare possibili guarigioni… a Milano che ci andavi a fare? Il turista? In una città di cui da bambino – a detta di uno dei suoi figli più fedeli, quel Bramieri/Carugati autentico re della barzelletta televisiva – leggesti essere una delle più brutte al Mondo?
Quando eri bambino, Milano erano i monologhi in TV di Walter Chiari. Una città in cui si corre, in cui il traffico è convulso. In cui folle di gente si assiepano perennemente lungo i marciapiedi delle strade, come cantava Memo con “Sapessi com’è strano / Sentirsi innamorati a Milano (…) Fra la gente / Tanta gente”. Altro che il traffico e la folla di Roma!. Milano: intensa e frenetica, come il parlare di Walter, come la sua loquela. Tua madre diceva sempre che non riusciva a seguirlo (Walter): perché raccontava troppe cose e con troppa fretta. Lo ammirava come personaggio, anche se essendo una persona dello spettacolo…
E poi Milano erano i palleggi bianco e nero di Rivera e Mazzola, con le sequenze al San Siro, alla domenica sera, prima della scuola all’indomani. Quasi tutti i tuoi amici tifavano per l’Inter di Herrera. Uno di loro poi ti disse che non avrebbe mai tenuto per l’Inter, che era la squadra dei ragazzini: lui, della Juventus…
Milano era però anche Enzo. Non tanto e non solo il Vengo anch’io… no: piuttosto era quella sua comparsata – proprio in un’osteria dei Navigli – nel film di Lizzani, dal libro di Bianciardi; erano le sue ballate, tristi e allegre al contempo. Tristi perché – fra pali e bande dell’ortica, fra vagabondi che portavano scarpe da tennis e ragazzi padri… – finivano quasi tutte male: arresti, uccisioni, tragedie erano all’ordine del momento. Ma erano anche allegre perché, in quegli eventi tragici, c’era comunque intriso un amore per la vita che… da dove lo ricavava, Enzo? Quel medico cardiochirurgo pareva il succedaneo nostrano di Chris Barnard. Lui e il suo fratello di latte – il grande Giorgio, dapprima di Non arrossire, ma poi di quegli spettacoli teatrali in cui si faceva finta di esser sani e ci si rassegnava a non volare – gigioneggiavano i Blues Brothers denominandosi Ja-Ga-Brothers, chiedendo ossessivamente Una fetta di limone nel tè.
E poi Milano erano le canzoni di quel professore, il Roberto delle luci di San Siro, non quello calcistico ma quello della nebbia e della sua sensibilità, quando lo avevi ascoltato in TV affermare che “La parte migliore di ciascuno di noi è quella femminile.” Tanto che reclamò anche di volere una donna con la gonna!
Quando in quel luglio – a Roma caldissimo – prendi l’aereo da Fiumicino per Milano – ricordi se era Linate o Malpensa? Non importa: ma era il tuo primo aereo della vita, a trentadue anni (fino ad allora solo treni, automobili e metropolitane), mentre tuo figlio lo ha preso a quattro anni – sei come inebetito dall’emozione. Seduto, allacci la cintura di sicurezza. Forse qualcuno ti aiuta. Poggi la testa sullo schienale poco prima del decollo. Già: perché senti il rombo del motore. Parte. Piano. Poi aumenta. Sempre più. All’improvviso avverti una grande potenza che t’innalza. V’innalza a tutti. Osservi fuori dal finestrino – sei comunque vicino al corridoio – e vedi il paesaggio inclinato. Poi cominci a osservare il vuoto, il cielo, l’aria (!?!), le nuvole. Quando il tutto si raddrizza – è avvenuto? – siete ad alta quota. La voce del comandante dagli altoparlanti vi tranquillizza. Rasserena. È una voce amicale. Siete decollati.
La sera gliene parlerai a Lei, al telefono, dalla stanza d’albergo o dalla cabina.
Quando sbarchi all’aeroporto – il tuo bagaglio è a mano, del resto è solo una notte che pernotterai – ti dirigi direttamente ai taxi. La tua destinazione è a Città Studi, vicino piazza Piola, ti han detto. Il residence ComeSiChiamava ti aspetta. Lasci lì il bagaglio. Sono appena le nove del mattino e ti dirigi all’ufficio della tua azienda. Devi supportare le soluzioni sistemistiche dell’informatizzazione del progetto Langhirano. Sì: quelli dei prosciutti. Proprio. In sede incontri la collega che avevi intravisto una volta in ufficio a Roma. Ne approfitti per passare a salutare anche alcuni tuoi colleghi del corso, quello di qualche anno fa. Sai che sono di Milano. Sai che sono lì. Quindi vai. “Ciao, ciao… come state…” Saluti, baci, simpatia. Un po’ di stupore. Con uno vi vedete all’ora di pranzo.
Mangiate un panino a un vicino bar-tavola calda. Ma ciò che ti colpisce è il parlare. Bello? Brutto? Non sai… ma sa tanto della tua Milano , quella che avevi appreso in TV. Ascolti: “Ehi, poi ti porto all’idroscalo…”, fa un avventore – grasso e tondo (a Milano, certo, ci si nutre!), baffuto e capellone – al barista. E in te affiorano idee, ricordi… l’idroscalo di Ostia, quello di Pasolini. Storie di cronaca nera immaginaria ti vengono in mente. In quel viaggio in Liguria, in famiglia di quel tuo amico, al liceo: il padre e lo zio vi raccontavano che – loro, fiorentini – da bambini fantasticavano di vivere avventure criminose nei bassifondi di Milano.
I miti delle generazioni!
Tornato in ufficio, dopo il pasto, insieme alla collega raggiungete il CED per visionare il server: questo dovrà ospitare le applicazioni del progetto. La sala è ghiacciata. Un omino – simpaticissimo, sembra un piccolo Carugati (come diceva Bramieri? “Carugati ha deciso di scendere a Milano per rendere migliore una città altrimenti brutta, una delle più brutte al mondo!”) – vive praticamente lì, ibernato. Dice: “Qui si sta benissimo!” Certo, fuori sono trentacinque gradi – dove è finito il freddo di Milano? Quello di Totò e Peppino? – ma qui saranno dodici… Lo stesso omino aggiunge poi che “Qui, ci si rompe le balle. Io vivo fuori, via di qui, lontano. L’altro giorno, uno, si è gettato da uno di questi palazzi… perché si era rotto le balle!” Tu ascolti. E pensi in effetti al silenzio, al sole, alla desolazione, al deserto che hai visto in quelle strade: alti palazzi, anche belli, ma disadorni. Facciate e facciate, con balconi, piante, foglie e fiori, che… ma chi li cura? Certo: siamo a luglio, la gente sarà anche fuori. Ai laghi, al mare, a Milano Marittima, immagini, come un bambino che perpetua la fantasia.
E ne parli con Lei, alla sera, al telefono, quando ritorni nel tuo residence, prima di andare a mangiare una pizza… in quel bel locale a piazza Leonardo da Vinci? O Leonardo da Vinci era il locale? Boh… fa nulla. Tanto l’indomani si torna.
Così si chiude la tua prima eroica trasferta a Milano, con il battesimo del volo.
Le volte seguenti – tante, in verità – sarai un veterano, tanto del volo che di Milano.
Già dalla volta successiva la trasferta è più turistica. Ci sono altri colleghi. Insieme a loro inizi davvero a girare Milan by night. I Navigli, da Decio Carugati. È la volta del Duomo. Gotico. Neo-gotico. Imponente. Ma, nella piazza, stanno facendo dei lavori. Ci sono alte transenne che occludono gli spazi. E opprimono la vista. Tanto che, la medesima, ti appare – sì, vero – parzialmente angusta. Ma telefoni a Lei, sempre da una cabina (i cellulari sono di là da venire, siamo nel ’90). “Sono al Duomo”, le dici, “e vorrei ci fossi anche tu!”
Ma… ci sarà occasione, non c’è da temere. Intanto, nell’attesa, ti pasci di quella città: altre trasferte, altre escursioni. Che bella… te l’avevano detto nell’infanzia!
Con Lei – finalmente – vivi una bella trasferta a Milano: voi, insieme al vostro amico Andrea e a sua moglie. È nel ’94. L’occasione è un interessante corso sull’internal di HP-UX – un approfondimento su un importante sistema operativo – presso la sede milanese della Hewlett-Packard. Di giorno tu e il tuo amico siete al corso mentre le signore fanno le turiste a Milano e a Pavia; alla sera, tutti e quattro, siete in ristoranti del centro, nonché effettuate escursioni fra Porta Romana e Porta Genova. Persino a Como. E, quando passeggiate per le vie notturne di Milano, in te – è inevitabile, no? – risuonano le note de “Le strade, di notte, mi sembrano più grandi, e forse anche un poco più tristi…” Glielo dici romanticamente a Lei, che cammina al tuo fianco.
Ma di lì in poi, sul finire dei ’90 e i primi del 2000, tu cerchi di migliorare la tua posizione professionale, ponendo l’occhio oltre che al ruolo anche alla retribuzione. Così, in quei due-tre anni, cambi un paio di aziende. Allora sono molteplici le occasioni, ancora e sempre professionali, di viaggio a Milano. Corsi in centro in hotel di lusso – ricordi l’Andrea Doria – e alloggio nella via omonima in strutture di pregio – il Jolly. Spesso cenerai nella pizzeria napoletana di via Pergolesi. In futuro – oltre a condurvi Lei – una volta ci sarà l’occasione di condurci anche tuo padre; lui, in memoria del suo Vomero, familiarizzerà simpaticamente con il proprietario. Questi gli dirà: “Caro amico, al nord la risposta a Napoli è Milano!”
In quell’altra trattoria sui Navigli, Vecchia Milano, famiglia Bugatti, o come si chiamavano, ritroverai poi le atmosfere di Rivera e Mazzola: evocative foto in bianco e nero, nostalgiche, incorniciate e appese alle pareti bianche. Quei tavolini d’altri tempi ti ricordavano le trattorie della tua infanzia, fra Re di Roma e San Giovanni.
Altri corsi li effettuerai presso l’amena sede IBM, nella tenuta boschiva di Novedrate, nel comasco – rammenti quel ponte tibetano? – È tutto un susseguirsi ed escalation di crescita: professionale, economica, relazionale; e inizi a pensare che Milano non sia poi tanto male. Come anche in occasione di quel corso alla CISCO, nei pressi della stazione Garibaldi, con alloggio in via Paolo Sarpi; si è in procinto di passare dalla Lira all’Euro. A Milano è un inverno particolarmente freddo: preludi dei geli futuri?
Nel corso dei vari cambi di azienda, inciampi nelle inevitabili visite mediche. Quella oculistica evidenzia i tuoi problemi, a te che da venti anni indossi lenti a contatto morbide idrofile. Ma da qualche tempo…
“Uno dei migliori chirurghi della cornea è a Mestre…”, ti vien sottolineato. Telefoni, prenoti, vai. “Può provare a risolvere i suoi problemi con il suo ottico e le lenti a contatto rigide gas permeabili”, ti dice il professore. A Roma, sperimenti varie soluzioni del genere ma… va bene solo il primo giorno, perché al secondo… un chiodo negli occhi, forse, fa meno male. E tolta la lente, all’inizio non vedi neanche con gli occhiali, in quanto il tuo cheratocono – o degenerazione pellucida che sia – risulta dapprima pericolosamente schiacciato, poi deforma la superficie oculare in modo impredicibile. Alla visita successiva, a Mestre dal professore, procedi con la pianificazione dell’intervento chirurgico. “La farò operare a Milano da mio figlio…”
Così approdi di nuovo nella città di Meneghino. Stavolta per motivi chirurgici. E il chirurgo è figlio d’arte che persegue le orme paterne. “Io e altri colleghi abbiamo imparato facendo le scimmie ammaestrate attorno a mio padre”, ti dice.
Insieme a Lei iniziate la trafila – nuovi Viaggi della Speranza – verso Milano; nello specifico verso il prestigioso polo d’eccellenza del San Raffaele, presieduto da “Don Verzè, sacerdote legato tanto al Vaticano quanto a Fidel Castro”, ti dirà poi – nel corso di uno dei tuoi cinque interventi chirurgici – un simpatico vegliardo produttore di vino del veronese. Nei giorni di ricovero o di Day Hospital si fa inevitabilmente amicizia con gli altri pazienti.
Prima del ricovero tu e Lei alloggiate nella essenziale ma confortevole foresteria del San Raffaele, nei pressi di Milano 2, in quel di Via Olgettina che diverrà famosa per altri futuri trascorsi. Lei vi alloggerà anche nei tuoi giorni di ricovero. È lì che vedrete la prima forma di Metropolitana non presidiata bensì controllata unicamente da sistemi intelligenti automatici: da Cascina Gobba al San Raffaele, meno di sessanta secondi su un binario a porte chiuse che si aprono unicamente in corrispondenza delle entrate dei vagoni, solo quando giunge il treno.
Le trafile di operazioni chirurgiche oculari si svolgeranno fra il 2001 e il 2005. Nel corso di alcune avete modo di visitare la Basilica Romanica di Sant’Ambrogio, “là, fuori di mano”, aveva detto due secoli fa il poeta che – già allora – apriva anche al nemico in segno di una umanità universale… e chissà, oggi, cosa direbbe! E hai modo di gustare – già, proprio così – l’isolamento acustico quando entri nella corte che prelude alla basilica: il rumore del traffico esterno pare dileguarsi, scomparire e dare spazio a un silenzio sovrumano, secolare, in cui c’è posto solo per il volo degli uccelli, lassù, sul campanile.
Altre volte conducete con voi anche vostro figlio. Lui rimarrà entusiasta di alcune specie animali presenti nell’oasi zoologica – non dimenticherà il lama, in quel recinto, con le sue spettacolari emissioni di gas – dell’amena Foresteria. E che bella, anche se disagevole, quella notte a Milano sotto la neve, ricordate?
I Viaggi della Speranza per i tuoi occhi, in quel di Milano, culmineranno con il rigetto corneale all’occhio destro, aumento pressorio e danneggiamento irreversibile al nervo ottico. Le tante visite private dal simpatico e bravo oculista Flavio – specialista dell’ipo-visione e della contattologia – tra Lima e Stazione Centrale, nei pressi di Piazzale Loreto – reminiscenze della Storia ti assalgono – non sortiranno l’effetto desiderato. Ma queste sono altre storie… e purtroppo altri professoroni confermeranno.
Di altre cose – della futura malattia di Lei, per cui siete tornati a Milano in altri ennesimi Viaggi della Speranza – ne hai già parlato molto. Altrove. Tuttavia, anche qui, in breve qualcosa puoi dire. Già, in quanto, dimenticato e archiviato il problema dei tuoi occhi, alcuni anni dopo, Milano… è anche per Lei…
La trasferta da quel luminare del peritoneo – chirurgo generale e oncologo, originario di Messina ma saldamente trapiantatosi nella città ambrosiana – da principio è, come del resto tutte le altre visite oncologiche, pregna di speranze. Alla fine, però, è densa di delusioni. Oltre ai quattrocento euro della visita, ci sono le illazioni – il suo “Uhm” a sentirne il nome – a carico del collega di Roma, che avrebbe sbagliato l’intervento; il tutto poi si rivela fallace e probabilmente millantatorio. Ma anche la durezza – tanto epidermica che profonda – del soggetto, avaro di sorrisi, di parole, di speranze: “Dottore, mia moglie guarirà?”, chiedesti; “Non lo so” rispose mentre scriveva i suoi appunti diagnostici, senza sollevare minimamente lo sguardo dal foglio e dalla punta della sua penna. Certo: deformazione professionale… devono difendersi dalle durezze del proprio mestiere, questi specialisti…
Milano, a quel punto, vi pare di conoscerla: per voi è quasi diventato un quartiere della vostra città. Così, ancor più, quando mesi dopo – meno di un anno dopo, nell’ultima disastrosa fase della malattia che segnerà la china irrecuperabile – siete costretti a raggiungere prima lo IEO, fuori città, poi l’INT, nel cuore. A volte Lei andrà sola, in queste trasferte, cocciuta e ostinata come non mai, a fare chemioterapia, controlli: altre volte, per tua insistenza e infine per inequivocabile necessità, l’accompagnerai. E allora saranno i dolori terminali a farsi strada, non lasciandovi in alcun luogo, rimanendo con voi sul tram, sul taxi, all’uscita o all’entrata della Stazione Centrale, lungo quegli scorci cittadini che preludono alla Svizzera, ai Laghi, alle amenità cantautoriali e autoriali, attoriali e barzellettistiche, calcistiche e spettacolari che tu avevi ascoltato e sognato da bambino. E tutto questo ti farà ben sperare: ti illuderà che – no, certo – queste cose non possono tradirti; non possono fare del male a Lei, all’amore tuo. A meno di ascoltare – da fuori della radiologia – le sue urla di dolore quando, pochi giorni prima dell’esito finale, Lei sta effettuando la TAC: la superficie del letto diagnostico è troppo dura e inospitale per le sue lesioni cutanee – a casa dorme si e no due ore a notte nel letto con cinque sei cuscini – che ormai la tormentano e non le danno minima tregua. Come nell’ultima sosta – quasi un frammento di una rediviva vacanza dei tanti decenni precedenti – in quella tavola calda, prima del treno per Roma: pizza, patatine fritte e birra… come foste ancora in uno dei vostri viaggi, vero, amore mio?
Resta nulla. E tutto. Il dileguarsi delle cose, delle persone, soprattutto dei medici, dei chirurghi e in particolare degli oncologi. Rimane il ricordo di quando, fuori, lungo il marciapiede dell’INT – tra la tanta gente della Milano della tua infanzia, quella cantata da Memo – Lei ti corre incontro a braccia aperte: è gaia e sorride perché ha appena completato la prima somministrazione del – per Lei – nuovo chemioterapico; ma tu hai la morte nel cuore, perché la responsabile oncologica ti ha appena detto che non c’è speranza, è solo questione di un tempo “X” e allora hai sceso i cinque piani a piedi senza connettere e ti sei attaccato al telefono con i vostri fratelli finché, da lontano, non hai scorto il suo sorriso, il suo volto, i suoi occhi e chiudi la telefonata, le corri incontro, la stringi a te e la baci, con tutta la delicatezza e l’amore del mondo.
“La vita è una cosa sporca”, le dirai la volta successiva, osservando l’innocenza sul suo viso ancora speranzoso, dopo tu aver ricevuto l’estremo commiato (“Non c’è più spazio per alcuna sperimentazione, caro signore”) dalla responsabile, ultimo appiglio e baluardo illusorio.
Il ricordo; tanti ricordi, di Milano nella mente; dal ’90 al 2016. Oggi, come allora; come se insieme – tu e Lei – foste ancora seduti in quel caffè della stazione: quello che le piaceva tanto. Perché, in fondo, malgrado le situazioni, entrambi avevate imparato ad amarla e ad apprezzarla, quella città.
FINE
[Fabio Sommella, marzo 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
Alla sua prima esperienza di pubblicazione di un libro di prosa narrativa, edito da Kubera Edizioni in questo inizio di 2019, Elena Vannimartini è autrice de L’Herbaria. Diciamo subito che è un lavoro semi-narrativo, collocandosi esso in uno spazio intermedio, vale a dire fra rivisitazione finzionale di un evento di fitoterapia naturale e fedele resoconto del medesimo.
In una dimensione fortemente alternativa rispetto alla cultura dominante – verde, come l’ambita magia stregonesca dell’autrice, nonché protagonista – densa di pur vaghe evocazioni di figlia dei fiori neosessantottina del nuovo millennio, con legittime velleità culturali di collocarsi fra mitologia e antropologia, tra sapori di pozioni, infusi e decotti alla Merlino e alla Morgana, all’interno di una pretesa linearità volutamente didascalico-pedagogica, l’autrice esplica e raccoglie una serie di appunti sul campo di latente impronta, appunto, antropologica. Ma se, mentre si scorrono le pagine successive a quelle dialogiche iniziali, echi del castanediano A scuola dallo stregone lambiscono la mente del lettore, non si possono neanche escludere reminiscenze del monicelliano Speriamo che sia femmina, specie nelle parti relative all’evento vero e proprio. L’incontro con la Maestra Erborista e con la piccola comunità femminile che fa da pubblico e coro, suggellerà e fregerà infine Elena della qualifica, come recita il titolo del libro, di Herbaria, vale a dire di medichessa delle erbe e delle loro proprietà cosmetico-salutari. In questo modo prende piede, si consolida e viene simpaticamente resocontata un’esperienza tutta al femminile. Corollario sono le ricette e l’utile glossario finale.
Intrisa di una certo non nuova ma comunque speranzosa utopia della contemporaneità, L’Herbaria è un sogno lungo un giorno, a cui si augurerebbe di cuore di avere ulteriori e fecondi seguiti; ma è comunque una collocazione temporanea che rivela velleità mai sopite da parte di un’indole caparbia, che non si placa, ammirevole per la propria testardaggine e per il suo amore per la natura: gli animali, i cani, l’aia, l’orto… Ma il lettore volenteroso può leggerci anche un ininterrotto sogno trans-generazionale e di genere che si perpetua nel tempo: una gaia carezza – sorridente e solare – che si distende sulla coscienza, abbracciandola come in una nuova Sweet Water di leoniana memoria – racconto filmico che consacrava appunto i cambiamenti epocali a cavallo del ’68 – ai confini di una frontiera esistenziale che, anche in questo nostro tempo, è sempre di là dall’essere superata e risolta.
[Fabio Sommella, 20 marzo 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

Era il digradare d’un quartiere urbano – una volta periferico, poi semicentrale – verso l’agro romano. Questo era stato caro al poeta tedesco, tanto da cantarlo in qualche sua opera. Laggiù, tra quei saliscendi verdi, m’aspettavo sempre d’incontrare qualche legionario romano, scappato non si sa come al Tempo e alla Storia. In quel frammento di consolare poi – tra Re di Roma e Colli Albani, dove da principio s’aspettava anche il pullman pei Castelli – annusai e concepii il mio concetto di città. Ma di lì a breve furono lunghi decenni nell’area metropolitana, tra i vagheggiati ricordi, nuove e diverse esperienze, amicizie, immaginazioni. Frascati crebbe nel cuore, mentre pure comparivano piaghe e ferite. L’università romana sembrava lontana, come se fosse vissuta dall’esterno. L’incontro con lei fu la giovinezza, prima quasi negata, poi cedette alla maturità. Pertanto la vita divennero i tanti lavori, le varie aziende, le diverse sedi. Così furono nuovi sfasci, nel cuore e nella mente, ma imparai che anche Milano – al di là del mito – non è poi così male. E ancora sole, pioggia, vento, insieme a lei e poi a un magnifico figlio. Ma giunsero inesorabili nuovi conti, alcuni attesi, sebbene più in là; altri… sì… davvero insospettati, tremendi. Fra i peggiori. L’universo, più volte, sembrò implodere facendomi interrogare circa il senso. Fino alle rinascite. In questo festoso, ininterrotto, fluire.
[Fabio, 14 marzo 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
Non ho mai amato troppo il cinema d’azione. Sì: il genere avventuroso, spettacolare e quant’altro di simile. Ho sempre prediletto – alla Moretti, direi – il cinema d’idee, d’atmosfere, introspettivo.
Ma anche nella pletora di registi di film d’azione – più o meno recenti – nel bene figurano alcuni che, all’interno di quel genere, sanno o hanno saputo sapientemente ritagliare spazi introspettivi, intimistici, profondi. Due per tutti – tralasciando coloro che ricevono molti riconoscimenti e si ostinano a far solo ed esclusivamente quel genere e a non parlare mai d’altro, anche disponendo degli spazi – sono: Michael Mann fra gli stranieri; un altro è stato il nostro Damiano Damiani. Sono questi due,registi che hanno o hanno avuto una “loro propria e originale voce”.
Il primo – Mann – anche in film eminentemente d’azione o epici, come Heat – La sfida, Collateral o L’ultimo dei mohicani, riesce a creare spazi di riflessione, allargandoli sapientemente, toccando vette poetiche non ordinarie; esempi: il dialogo fra i personaggi di De Niro e Al Pacino in Heat…; l’epica e intensa sequenza finale, sull’orlo del baratro, ne … i Mohicani; l’intimismo misterico/poetico in sequenze di Collateral.
Damiano Damiani è stato invece, a mio avviso, uno dei pochissimi autori in grado di realizzare film sulla malavita organizzata, sulla mafia, senza annoiare mai, senza mai cadere nella retorica, nelle ovvietà. Pizza Connection, Un uomo d’onore, La piovra 1 restano rari esempi di come si debbano realizzare lungometraggi o fiction d’azione e spettacolari, “d’avventura”, senza mai eccedere nel fine a se stesso bensì accelerando quando si deve, rallentando quando è sentito, ampliando gli spazi del sociale, politico, poetico, intimista in modo convincente, avvincente, concertato fra tutti gli ingredienti del raccontare filmico. Damiani, tra le altre opere, è stato anche autore de La rimpatriata, 1963, e de L’inchiesta, 1986; questi, nei loro differenti generi, sono autentici capolavori.
Senza nominarli, altri registi, nel genere film d’azione/spettacolare, hanno un’unica omogenea e uniforme monotona voce, priva di qualsiasi originallità.
[Fabio Sommella, 12 marzo 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)