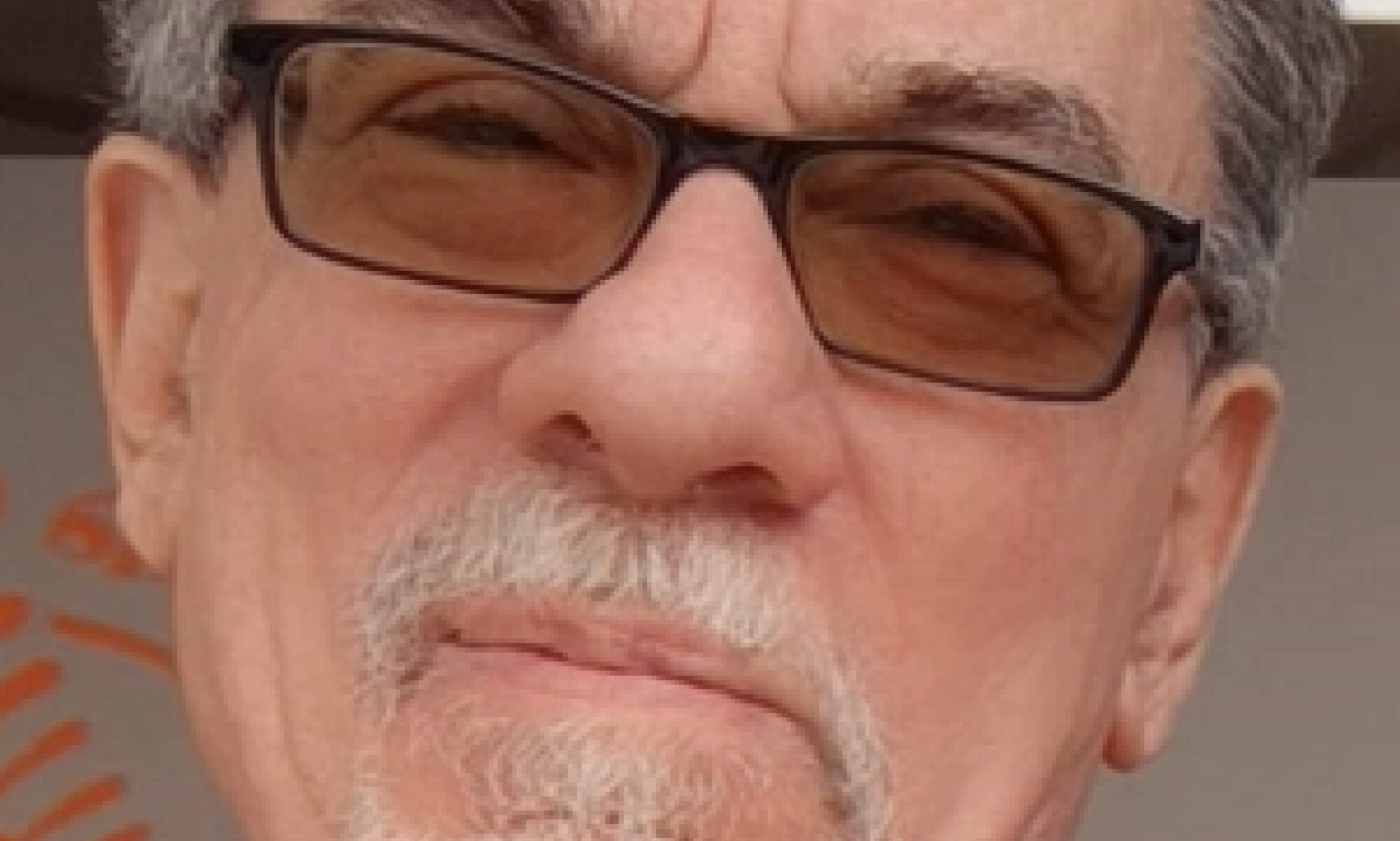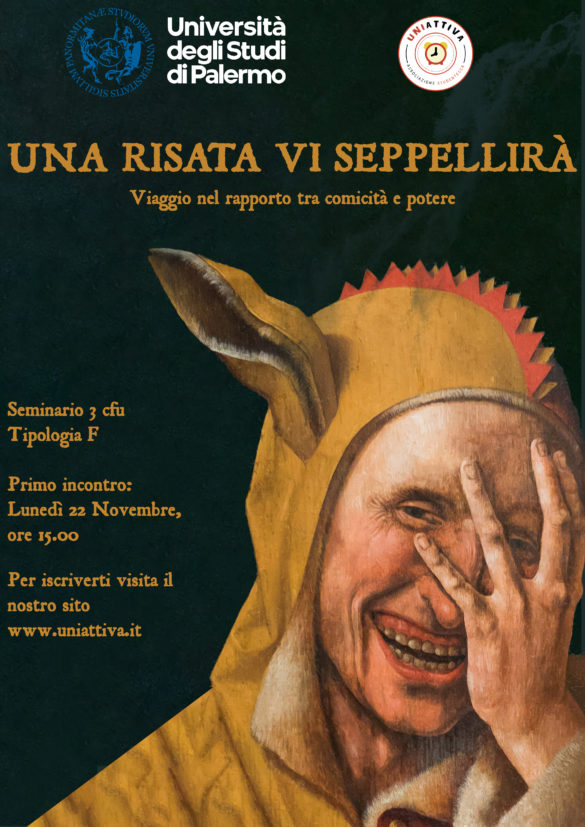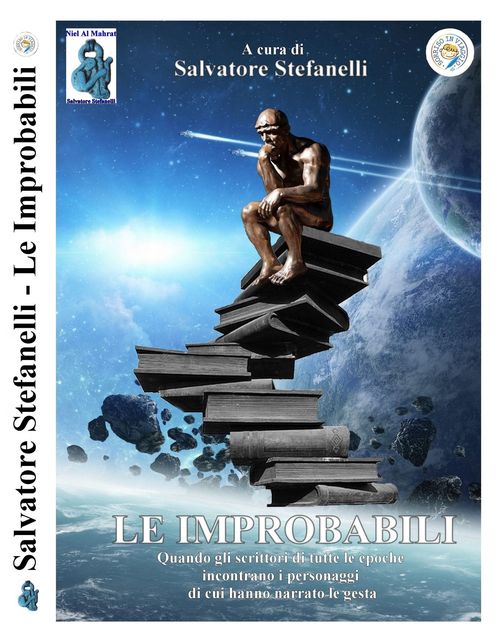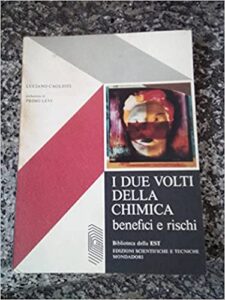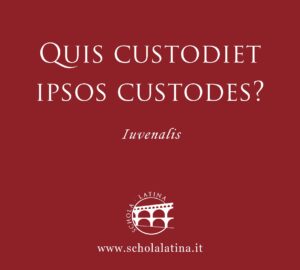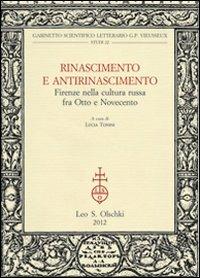Ieri, 12 giugno 2023, è venuto a mancare Francesco Nuti. Io sono stato un estimatore della sua arte, in particolare del suo film Tutta colpa del paradiso. Come ho avuto già modo di commentare sui Social, considero questo film un autentico capolavoro di poesia e simbolismi che, di sbagliato, ha solo il titolo e la locandina, i quali traggono in inganno rispetto alla bellezza, garbo e delicatezza dell’opera.
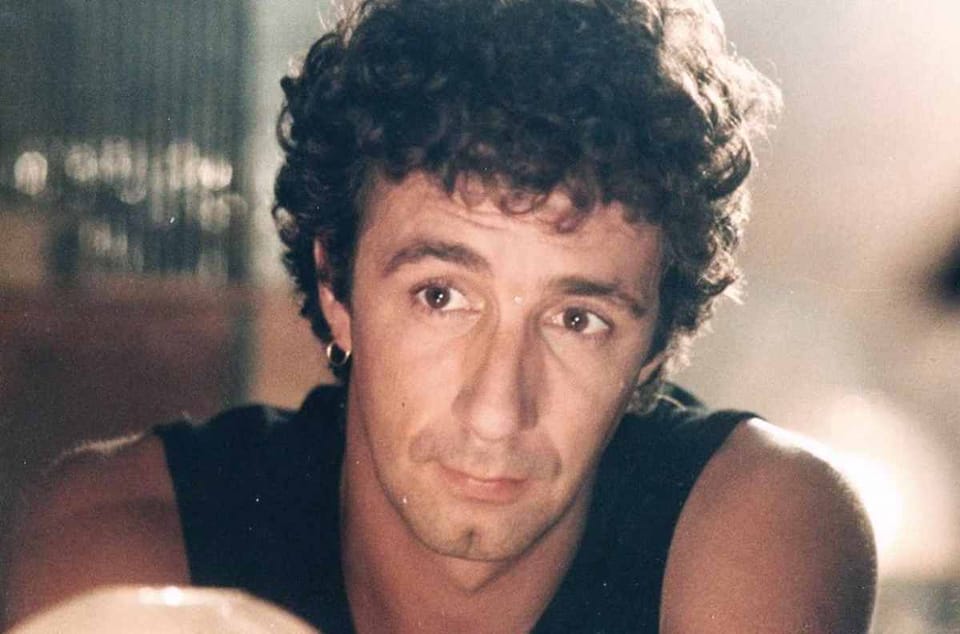
Mi fa piacere quindi pubblicare, qui di seguito, qualche contributo su Francesco e la sua arte.
Il primo è un estratto dal mio libro Il cambio della guardia che, nello scenario dell’evoluzione della Commedia all’Italiana, tratta proprio la mia lettura di Tutta colpa del paradiso.
Il secondo è un bell’intervento, dettagliato e accorato, dell’antropologa e mediatrice culturale Adriana Migliucci all’interno della sua pagina Facebook, intervento che ha stimolato ulteriormente il mio interesse per Francesco e che, pertanto, mi permetto di divulgare a mia volta (spero Adriana non se ne abbia a male ma, conoscendola, penserei davvero di no!) Questo bel contributo è corredato anche di un ulteriore scambio fra me e Adriana.
Non mi resta, quindi, che augurare buona lettura a coloro che vorranno incontrare queste nostre analisi e testimonianze e, rivolgendomi a Francesco con la medesima delicatezza che ha contraddistinto la sua arte, dire “So Long, Francesco: che la terra ti sia lieve!”
Fabio Sommella scrive di Tutta colpa del paradiso
In precedenza si è già accennato a questo film del 1985. Esso reca la firma, oltre che dello stesso Francesco Nuti e di un giovane Giovanni Veronesi, anche di Vincenzo Cerami[1], già autore circa un decennio prima del famoso Un borghese piccolo piccolo, portato sullo schermo da Sordi e Monicelli. Sulla scorta di un sapiente soggetto e di una robusta sceneggiatura, questo film brilla tanto per la coerenza narrativa quanto per il sapiente impiego dei plurimi elementi sottostanti, tutti elementi ruotanti attorno al tema del viaggio alla ricerca di un figlio. Questo itinerario ha però origine da un claustrofobico incipit nel carcere e, attraverso alterne e anche molto ironiche vicende, conduce fino all’allegorica conclusione in vetta al Gran Paradiso. In tutto ciò si ritiene che l’apporto di Cerami sia fondamentale proprio in relazione all’affermazione dei plurimi elementi che, tutti insieme, vanno a costituire l’ampio e articolato preambolo del film.
Ma vediamoli con il dovuto ordine, questi elementi plurimi!
L’inizio è nel citato carcere, assieme al, da principio, minaccioso compagno (un detenuto incarcerato per un feroce omicidio) di cella del protagonista Romeo Casamonica, interpretato dal medesimo Francesco Nuti (certamente nel suo periodo artistico più smagliante).
Giunge poi il commiato tra i due. Esso sarà di estrema amicizia, con il dono del poster di Fausto Coppi da parte di Romeo all’altro; quest’ultimo ricambierà con l’armonica a bocca, elemento in seguito simbolicamente pregno di vibrati e vibranti significati.
Segue una casa, antica abitazione (di cinque anni prima) non più ritrovata da Romeo: al suo posto ci sono palazzoni[2]. «Qui son passati gli americani», dirà a Romeo uno stravagante stralunato amico netturbino, incontrato nel quartiere, una landa suburbana che rimanda all’aspro e anonimo sapore d’un dormitorio pubblico.
Romeo, alla disperata ricerca di suo figlio Lorenzo – da recuperare a dispetto di un suo presunto-simbolico crimine di rapina a mano armata[3] – che praticamente non aveva conosciuto, dovrà recuperare i suoi pochi oggetti personali. A tal fine scenderà in una sorta di post-moderni inferi, vale a dire i profondi sotterranei-scantinati dei suddetti palazzoni del quartiere dormitorio. Egli, come un novello Dante il cui tragitto è però capovolto, sarà provvisoriamente accompagnato da una donna-nana, anche lei sorta di Beatrice capovolta. Ma questa non giungerà alla meta con lui, poiché anch’essa teme quelle sordide profondità dove, infine, una schiera di loschi punk apparentemente lo minacceranno, per poi in realtà lasciargli spazio e recuperare le sue poche e perdute cose, i propri affetti personali.
Ciò fatto e adempiuto, Romeo si recherà presso l’assistente sociale, una dura quanto convincentissima Laura Betti – ormai da tempo “orfana” di Pier Paolo Pasolini – la quale gli negherà la conoscenza del luogo adottivo dove vive adesso suo figlio Lorenzo. Ma ciò è poco male: Romeo è stato in prigione ed è ormai avvezzo alle durezze della vita. Così nottetempo, si introduce negli uffici dell’assistente sociale e, consultando i primi pur rudimentali personal computer, svelerà a sé stesso che il suo Lorenzo è stato adottato da una onesta e ligia famiglia che risiede in Val D’Aosta, sulle amene vette del Gran Paradiso.
Fin qui il preambolo/prologo del racconto, da cui il vero nucleo del film prende poi piede e si sviluppa secondo una forte e poetica quanto umoristica vena, lasciando spazio a plurimi significati, secondo la più nobile e matura Contemporaneità o Postmodernità, nonché naturalmente secondo una romantica vicenda amorosa. Questa avverrà quando Romeo/Nuti raggiungerà il rifugio del Gran Paradiso. Qui egli conoscerà l’affascinante Celeste, impersonata da Ornella Muti, madre adottiva di Lorenzo mentre Alessandro, impersonato da Roberto Alpi, padre adottivo del ragazzo, è un brillante ricercatore in etologia. La nuova famiglia risiede e vive, temporaneamente, sulle vette del Gran Paradiso in quanto il brillante etologo ricerca il “famigerato” stambecco bianco, rarissimo esemplare di una specie animale di cui ne nasce uno ogni cinquecento anni. Esso, lo stambecco bianco, proprio a causa di questa sua anomala e stravagante sembianza, viene bandito fin dalla nascita dal gruppo della sua specie.
La simbologia filmica, ben si comprende, è potente: l‘interscambio e il connubio, immediato, fra il protagonista Romeo e lo stambecco bianco saranno sempre più spinti in avanti e marcati fin quasi a confondersi e sovrapporsi con il prosieguo del racconto. Questo sarà naturalmente inframmezzato da tante gustose annotazioni, tra cui il ripetuto tormento del protagonista da parte di fastidiosi insetti volatili.
Il connubio Romeo/stambecco bianco si avrà poi al termine del racconto, dopo che Romeo, ormai persuaso della sua scelta, avrà rinunciato a “riprendersi” il figlio. Ciò avverrà dopo l’unica e irripetibile notte d’amore con Celeste, notte d’amore di “trasgressione” delle regole approvate dalla comunità, “trasgressione” che in base a un’antica leggenda locale è concessa solo per quella notte dell’anno, festa di fine estate. Sarà questo un episodio connotato dalle vibranti note dell’armonica a bocca di Romeo. Dopo tutto ciò, Romeo lascerà il figlio Lorenzo, sereno e inconsapevole, nella sua – per il ragazzo unica e originaria – magnifica famiglia adottiva.
In definitiva Romeo avrà stabilito con Lorenzo “solo” un’intensa e sincera amicizia. Successivamente a evocativi ed eroici echi – inerenti a memorie sportive circa Fausto Coppi, memorie dal sapore epico ed atavico riecheggianti certamente l’infanzia di Nuti stesso – solo Romeo, a dispetto di qualsiasi scientifica ricerca etologica, avvisterà lo stambecco bianco.
I due, Romeo e lo stambecco bianco, comunicheranno all’interno di una splendida sequenza alternata di empatiche inquadrature, laddove i due “volti” – dell’umano e del caprino – si confonderanno in un’unicità di sovrapposizioni ed espressioni: ciò a significare che, in realtà, la natura e l’amore per la vita non hanno confini o separazione nell’umano o nell’animale ma sono, più probabilmente, un eterno e scambievole gioco universale, una eterna ghirlanda brillante, come per altri versi si potrebbe leggere l’importante testo di Douglas Hofstadter[4]. È questo scambievole gioco universale – paradisiaco – che si deve saper cogliere con l’anima piuttosto che con la pura e sola razionalità.
L’apporto di questo film di Nuti, insieme a Cerami e a Veronesi, al cambio della guardia, avvenuto nel grembo della “leggera” Commedia all’Italiana degli anni ’80, appare notevole e non si può trascurare. Emblematico trionfo della Contemporaneità postmoderna sarà infatti la sequenza di chiusura. Qui Romeo, avvistato lo stambecco bianco e avvenuto il connubio con lui, ormai definitivamente avviatosi sulla via del ritorno, la via di discesa dal Paradiso, si è appena staccato dal figlio e dai suoi genitori adottivi, lasciandoli tutti insieme, senza personali remore bensì serenamente, alla loro vita indipendente e autonoma. È adesso che Romeo, per l’ennesima volta, viene aggredito dai fastidiosi insetti volatili che lo hanno già tormentato. Romeo – e qui si coglie tutta la genialità del meta-linguaggio di Nuti, Cerami e Veronesi – schiaccerà il fastidioso insetto volatile ma lo coglierà non in uno spazio intra-diegetico bensì extra-diegetico, vale a dire proprio sull’obiettivo della camera, da cui, noi spettatori, lo stiamo scrutando; ciò a meta-significare – in una superba coda extra-diegetica – che gli insetti, che hanno tormentato il protagonista in precedenti sequenze, eravamo noi stessi, noi spettatori che non eravamo in grado di approvare l‘operato esistenziale, così altruista e generoso, del personaggio Romeo. È così che, concedendogli ampio e grande omaggio, il meta-linguaggio e l’extra-diegesi supportano la Contemporaneità postmoderna.
[1] Il quale ritroveremo anche in alcuni dei migliori frutti filmici di Roberto Benigni.
[2] Come, per altri versi nella realtà, nella più antica (vent’anni prima) celentaniana canzone Il ragazzo della via Gluck
[3] Crimine tutto sommato analogo ai simbolici delitti compiuti dal surreale Michele Apicella di Nanni Moretti in Bianca.
[4] Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un’eterna ghirlanda brillante, 1979.
[Fabio Sommella, Il cambio della guardia, pp. 145-150, Caosfera Editore, Vicenza 2017; Amazon 2019]
Adriana Migliucci scrive di Francesco Nuti
Fabio Sommella –> Adriana Migliucci
Se tu non ci fossi, si avrebbe il dovere d’inventarti!!! ![]() Scherzi a parte, il ricordo di cui ci partecipi, ma soprattutto l’espressione dei tuoi stati d’animo a quell’esperienza, sono di una levità e sacralità umane molto rare davvero. Io, oltre ai film (in primis quel Paradiso, pure rarissimo come poeticità e simbolismo), credo di aver percepito Francesco in alcune interviste, sui giornali e in TV, nel corso degli aneddoti ufficiali in cui, come anche nelle sue migliori opere, emergeva il “non detto”, i silenzi, il “sottratto”. Uno degli elementi della sua poetica era l’oscurità, il notturno, espressione di un profondo senso di solitudine che s’incarnava nella cella d’un carcere o, all’opposto, nelle vette del Gran Paradiso, dove uno stambecco bianco – “Ne nasce uno ogni 500 anni’ – fa scorribande notturne, e infine si manifesta e si specchia in lui – due sguardi isomorfi che rispecchiano più profonde similitudini – a dispetto di ogni etologo e ricercatore di professione.
Scherzi a parte, il ricordo di cui ci partecipi, ma soprattutto l’espressione dei tuoi stati d’animo a quell’esperienza, sono di una levità e sacralità umane molto rare davvero. Io, oltre ai film (in primis quel Paradiso, pure rarissimo come poeticità e simbolismo), credo di aver percepito Francesco in alcune interviste, sui giornali e in TV, nel corso degli aneddoti ufficiali in cui, come anche nelle sue migliori opere, emergeva il “non detto”, i silenzi, il “sottratto”. Uno degli elementi della sua poetica era l’oscurità, il notturno, espressione di un profondo senso di solitudine che s’incarnava nella cella d’un carcere o, all’opposto, nelle vette del Gran Paradiso, dove uno stambecco bianco – “Ne nasce uno ogni 500 anni’ – fa scorribande notturne, e infine si manifesta e si specchia in lui – due sguardi isomorfi che rispecchiano più profonde similitudini – a dispetto di ogni etologo e ricercatore di professione.
Adriana Migliucci –> Fabio Sommella
Grazie di cuore per le tue parole su di me e concordo pienamente con quanto scrivi della sua arte e umanità. Tutta colpa del paradiso credo che sia un capolavoro assoluto e so che c’è quel film dietro alla scelta del nome di molti quarantenni-trentenni di oggi che si chiamano Lorenzo!

[Adriana Migliucci, Tra i vari bellissimi strani lavori che ho… – Adriana Migliucci | Facebook]
[A cura di Fabio Sommella, 13 giugno 2023]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)